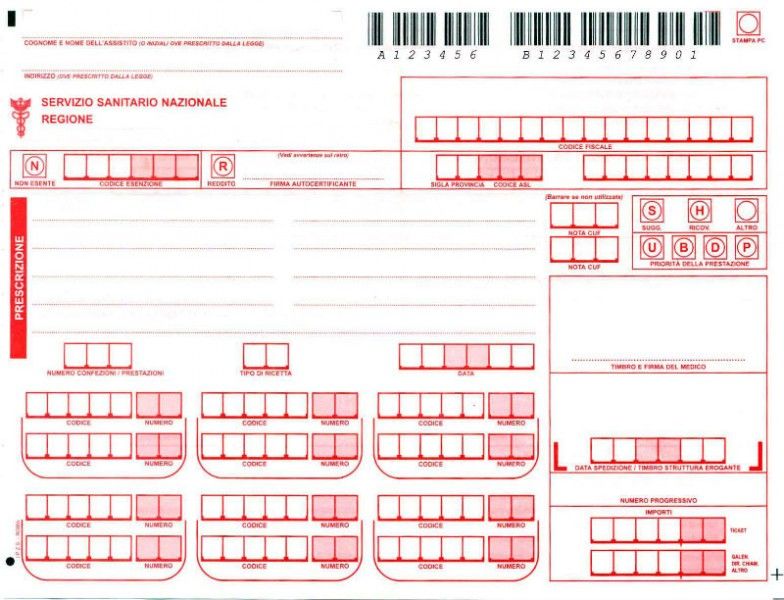Opinioni & Commenti
Terra Santa, la pazienza non basta più
Il suo successore Abu Mazen apparve come una svolta, anche se apparteneva alla stessa generazione dei settantenni che, a suo tempo, avevano fondato Al Fatah. Al posto della divisa e della Kefiyah, Abu Mazen porta la giacca e la cravatta. Ama il discorso concreto, anziché la retorica. Preferisce la gestione delle cose ai bagni di folla. Soprattutto non ha mai nascosto la sua contrarietà alla cosiddetta militarizzazione dell’Intifada, cioè alla sostituzione delle bome alle pietre. Il popolo vuole mangiare. Uccidere non è il nostro passatempo preferito, aveva già detto al tempo di Arafat.
Il vecchio Sharon, che mai in vita sua aveva voluto stringere la mano ad Arafat, nemmeno con la profilassi di un guanto, aprì subito una linea di credito verso il nuovo presidente palestinese. Lo incontrò due volte appena eletto e, nello stesso discorso del gennaio scorso in cui annunciava il ritiro israeliano da Gaza, il capo del governo israeliano ammetteva apertamente per la prima volta il principio del ritiro israeliano dai Territori seppure con il buon senso delle scelte obbligate. Noi non vogliamo disse in Parlamento dominare milioni di palestinesi la cui popolazione raddoppia a ogni generazione.
Ma, dopo il disgelo iniziale, ora le relazioni israelo-palestinesi sembrano di nuovo tornate a un punto morto. L’intesa fra i due leader per bloccare, da un lato, gli attentati terroristici e, dall’altro, gli assassini mirati contro i supposti attentatori, ha fatto del 2005 l’anno meno cruento degli ultimi cinque anni di Intifada, nonostante le numerose violazioni della tregua.
Ma la pretesa di Sharon di ottenere da parte di Abu Mazen lo smantellamento delle organizzazioni estremiste e l’arresto dei terroristi come premessa alla riapertura di un negoziato si è rivelata nei fatti una invocazione alla guerra civile fra i palestinesi. La scomparsa di Arafat, che controllava, con il suo autoritarismo e il suo denaro, i vari gruppi dei 50mila miliziani dell’autorità palestinese, ha dato il via agli scontri, anche armati, fra le varie bande come quello che in pieno giorno ha portato all’assassinio del cugino dell’ex-rais, Moussa Arafat. Dei poliziotti palestinesi in lotta perfino fra loro non sono certo in grado di affrontare con la forza i gruppi terroristici.
Abu Mazen intende ammansire l’estremismo con il dialogo e la responsabilizzazione nella gestione del potere. Tenta questa difficile operazione di seduzione anche nei confronti del gruppo di Hamas che può essere addirittura il vincitore delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale palestinese del gennaio prossimo. Ma, per avere qualche possibilità di successo nella sua sorniona opera di mediazione, Abu Mazen dovrebbe vantare qualche altro risultato tangibile nella liberazione dei Territori Occupati, dopo il ritiro israeliano da Gaza, mentre in realtà il governo israeliano da un lato evacuava 8.000 coloni da Gaza e quasi contemporaneamente ne impiantava 12.000 in Cisgiordania, soprattutto in quella periferia di Gerusalemme Est, che dovrebbe essere la capitale del futuro Stato palestinese.
Ora la detronizzazione nel partito laburista dell’ottantaduenne Shimon Peres a vantaggio dell’improvvisato leader Amir Peretz, che vuole le elezioni anticipate, apre una fase di grande incertezza politica anche in Israele, diviso fra la destra di Netanyahu, il centro di Sharon, la sinistra di Peretz.