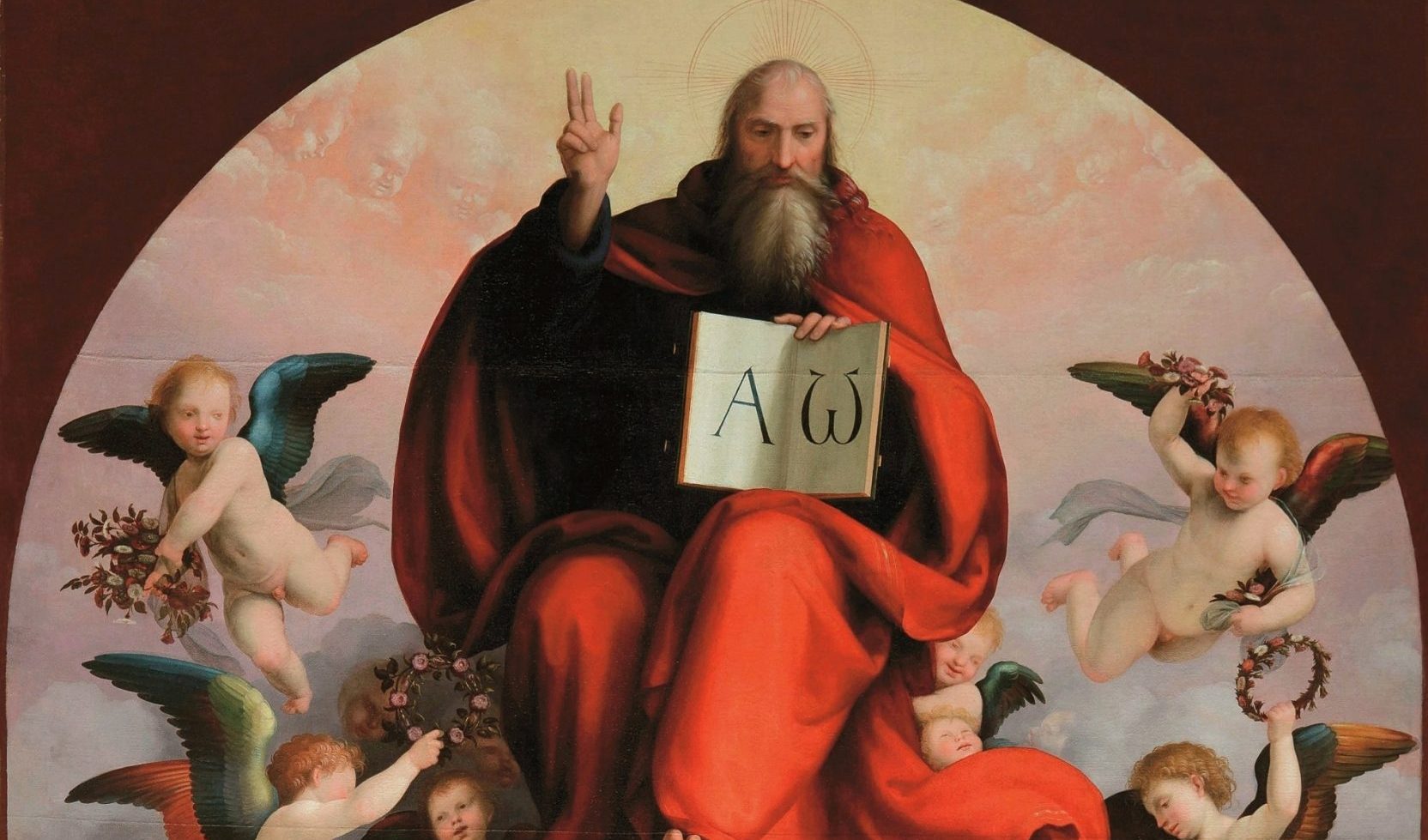TULPAN

DI FRANCESCO MININNI
Come ne «La storia del cammello che piange», come ne «Il cane giallo della Mongolia», come ne «Il prigioniero del Caucaso» i ritmi sono quelli della terra e della vita interiore. In più, in «Tulpan», è presente la tematica del confronto/contrasto tra la vita tradizionale propria delle steppe del Kazakistan e il sogno di un’esistenza, che a questo punto definire normale è quanto mai improprio, segnata dai marchi della civilizzazione. Un po’ quello che accadeva in «Urga» di Mikhalkov e nei film anglo-pakistani del genere «East Is East» o «Sognando Beckham». Ma Dvortsevoy, esordiente nel lungometraggio che chiameremo di finzione, ha una certa esperienza nel ramo documentario. Ciò lo porta a non forzare i toni immergendo il tutto nel ritmo della steppa e soprattutto a non deviare mai dalla narrazione in loco. Se Dersu Uzala veniva irrimediabilmente traumatizzato dall’incontro con la civiltà a casa del nemico, le scelte di Asa sono interamente confinate negli spazi kazaki. Per lui la civilizzazione è semplicemente un ricordo.
Asa è un kazako che, di ritorno dal servizio militare in Marina, ritrova la sua famiglia, la sua terra, i luoghi nei quali si presuppone che debba spendere il resto della vita. Ma a quanto pare il sapore della mela proibita gli è rimasto in bocca e lo porta a meditare l’abbandono della terra natia. Non prima, però, di aver fatto un tentativo ai suoi occhi di sicuro successo: la ricerca di una moglie. Ora, chi come noi è abituato alle modalità correnti, forse troverà difficile entrare nell’ordine di idee: ma nei dintorni (che vuol dire centinaia di chilometri) l’unica donna in età da marito è Tulpan. E la ragazza, ritrosa e schiva fino all’isolazionismo, non gradisce le orecchie a sventola di Asa. Da qui una serie di tormenti interiori che portano il giovane, stanco di greggi, polvere e tempeste, a maturare la decisione di andarsene. Dovrà però fare i conti con il richiamo della terra, capace di riecheggiare da più parti. Che sia la nascita di un agnellino o l’attaccamento alla famiglia, è un richiamo difficile da ignorare.
«Tulpan», vincitore della sezione «Un certain regard» all’ultimo Festival di Cannes, ha precedenti che non si possono ignorare. Ma ha dalla sua una forza narrativa che riesce a far sì che anche lo spettatore «civilizzato» (dove le virgolette hanno una connotazione sicuramente ironica) entri nel meccanismo kazako riuscendo, foss’anche per il breve spazio di due ore, a comprendere il punto di vista della terra. È il motivo per cui la scelta di Asa, che potrebbe far pensare a un colpo di spugna su sogni e aspirazioni, assume invece un significato etico, etnico e psicologico ben preciso. Si dovrà comunque tener presente che nelle steppe del Karakistan la vita scorre sui binari del necessario, mai del superfluo. E che quindi la volontà di rimanere non equivale a una sottrazione, ma a un semplice adeguamento allo stato naturale e alla necessità che certi ritmi, certe tradizioni, certe necessità siano in qualche modo tramandati e quindi perpetuati. Anche se Asa, che identifica con l’uniforme da marinaio tutto ciò che in cuor suo sembrerebbe essere una nuova vita o una vita nuova, sembra convinto di «dover» partire, avrà comunque l’accortezza (più ancora: la necessità) di leggersi ancora più profondamente per scoprire che un altrove potrebbe essere inappropriato. Questa non è paura, ma saggezza in embrione. Il bello di «Tulpan», che richiede comunque un’attenzione superiore alla media perché i ritmi non ci sono familiari, sta nella conclusione che cambiare per cambiare è sempre una sciocchezza. Talvolta, come ben sappiamo, ci vuole più coraggio per restare ad affrontare una vita che, per quanto dura, alla fine è quella giusta.
TULPAN (Id.) di Sergei Dvortsevoy. Con Ondas Besikbasov, Samal Esljamova, Ashkat Kuchencherekov. D/K/P/RUS/CH 2008; Drammatico; Colore