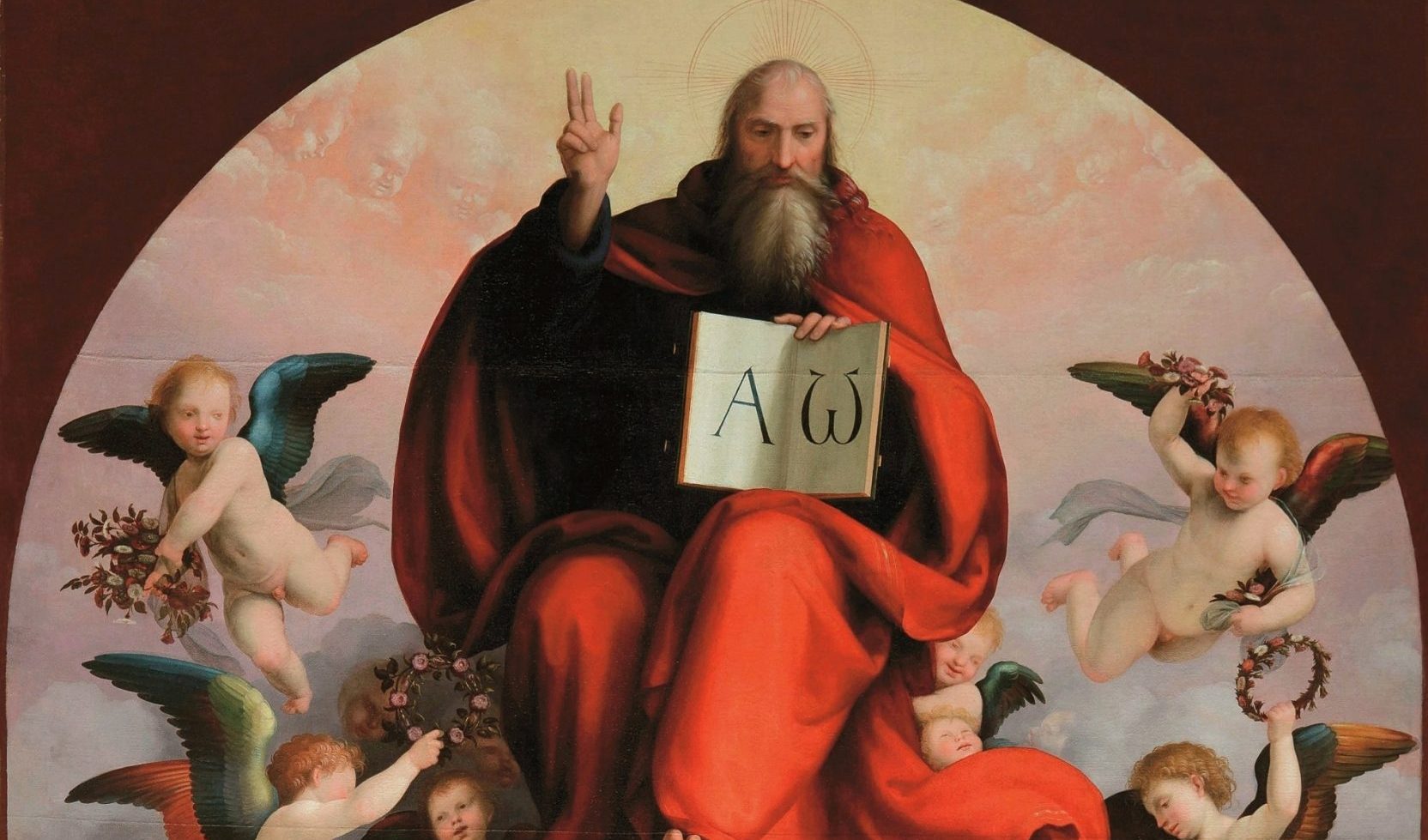IL NASTRO BIANCO

DI FRANCESCO MININNI
Michael Haneke, chi era costui? Secondo qualcuno un analista sociale che, pur di raggiungere i suoi obiettivi, non risparmia né violenze né crudeltà. Secondo altri un provocatore che si fa scudo dell’analisi sociale per rappresentare deviazioni di ogni genere con astuto compiacimento.
Molto probabilmente la verità sta nel mezzo: Haneke sarebbe un acuto analista sociale, ma non gli giova l’eccessiva insistenza su violenza e crudeltà soprattutto perché induce il sospetto di interessi meno analitici e più patologici. «Il nastro bianco» potrebbe cambiare in parte le cose. Per la prima volta Haneke si distacca dal contemporaneo e sceglie un periodo storico passato (la Germania del Nord nel 1914, alla vigilia dell’attentato di Sarajevo e quindi della Grande Guerra) nel quale brutalità e violenze non sarebbero altro che una sorta di rappresentazione simbolica della genesi del nazismo. L’argomento è delicato e tutt’altro che agevole, perché si presta a schematismi e banalità oltre che, come al solito, a compiacimenti. Ma al riguardo Haneke sceglie un tipo di rappresentazione che dovrebbe allontanare il sospetto: tutte le storie del villaggio da lui preso in esame non arrivano a una conclusione e, soprattutto, ogni atto di violenza, ogni brutalità, ogni crudeltà sono mostrati soltanto nell’esito. L’atto in sé rimane rigorosamente fuori campo. Ciò ha due finalità: da una parte l’autore non vuole mostrare i responsabili lasciando che sia il pubblico a prendere la propria decisione, dall’altra non vuole assolutamente che per chi assiste al film la violenza esibita possa rappresentare una valvola di scarico. Se c’è accumulo di tensione, lo spettatore se la terrà dentro e, magari, se la porterà a casa avendo così modo di riflettere su ciò che ha visto.
A dire il vero, il meccanismo potrebbe avere qualche controindicazione: neanche in «Funny Games» c’era un’esibizione compiaciuta di violenza, ma si rischiava di uscire dal cinema con la voglia di ammazzare qualcuno. «Il nastro bianco», invece, è nelle intenzioni un’analisi storica precisa.
In un villaggio contadino i personaggi di punta sono il barone latifondista e il rigidissimo pastore protestante. In una comunità contrassegnata da molte presenze infantili e adolescenziali, cominciano ad accadere avvenimenti strani. Il figlio minorato di una bambinaia è ritrovato gravemente ferito con il rischio di perdita della vista. Uno dei figli del barone è legato e percosso duramente. Un magazzino viene dato alle fiamme. Di questi eventi nessuno sa chi possa essere il responsabile. Di altri invece (la distruzione del raccolto di cavoli del barone) si sa benissimo di chi sia la colpa. Su tutto aleggia la rigidissima educazione data dal pastore ai propri figli. Il maestro di scuola, testimone e narratore, sa bene che da tutto ciò nascerà qualcosa di male. E lo sanno anche i libri di storia.
«Il nastro bianco», palma d’Oro a Cannes, può contare su uno straordinario bianco e nero orchestrato dal direttore della fotografia Christian Berger. E può anche contare su un gruppo di attori, adulti e ragazzi, che vanno a comporre un insieme di rara omogeneità, sia per la particolarità dei lineamenti sia per la notevole espressività. Da qui a invocare il capolavoro, però, intercorre la distanza del fossato scavato dalla vocazione provocatoria di Haneke, che alla fine dimostra di aver scelto un argomento complesso trattandolo in maniera qua e là troppo elementare. In questo caso, tuttavia, saremmo più propensi ad aprire all’autore un credito di fiducia. «Il nastro bianco» non è un capolavoro, ma neanche una compiaciuta galleria di perversioni. Qualcuno ha detto che i ragazzi del film mostrano una singolare assonanza con quelli, altrettanto pericolosi, de «Il villaggio dei dannati» di Wolf Rilla. Interessante analogia: un’altra cosa sulla quale riflettere.
IL NASTRO BIANCO (Das Weisse Band) di Michael Haneke. Con Susanne Lothar, Ulrich Tukur, Burghart Klaußner. AUSTRIA/GERMANIA 2009; Drammatico; Bianco e nero