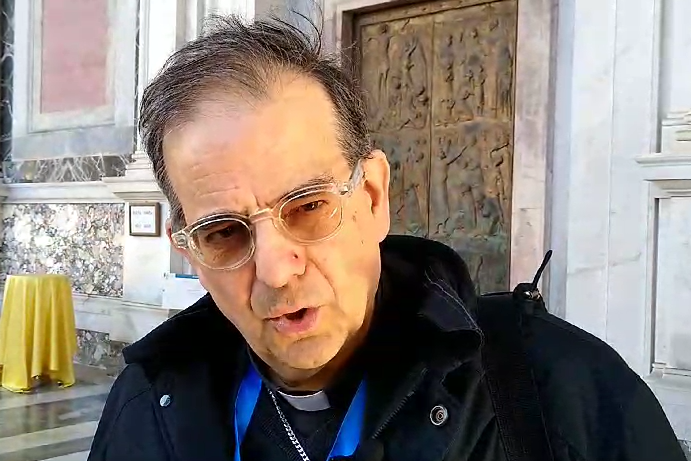Opinioni & Commenti
L’Iraq tra il male dell’occupazione e il peggio della disintegrazione
Anche le altre motivazioni, che sono state scoperte a mano a mano che la causa principale sfumava, lasciano almeno perplessi. Saddam era senza dubbio un feroce dittatore, ma troppo a lungo in passato è stato tollerato e persino talvolta coccolato, anche se poi, all’ultimo momento, ci siamo accorti che bisognava portare la democrazia in Iraq. L’idea di esportare un sistema politico con la guerra è stata da sempre un brevetto dell’estrema sinistra. Fu dei giacobini durante la rivoluzione francese. Fu dei trotskisti durante la rivoluzione russa. I conservatori finora si sono limitati al massimo, come Churchill, a difendere la democrazia con la guerra.
Se oggi i cosiddetti «neoconservatori» americani volessero ripulire il mondo da tutti i dittatori dovrebbero mettere in cantiere guerre per un paio di secoli.
Nè sembra che la guerra abbia aperto la strada alla soluzione del conflitto arabo-israeliano. Alcuni segni di moderazione, come la rinuncia di Gheddaffi alle armi di distruzione di massa o l’accettazione delle ispezioni sul nucleare da parte dell’Iran, non sono necessariamente legati all’effetto Iraq.
Dopo l’11 settembre nessun paese occidentale è stato vittima di un attentato terroristico grave, mentre nel resto del mondo, se si escludono l’Iraq ed Israele, gli ultimi pesanti attentati sono quelli di Casablanca e di Bombay alla metà dell’anno scorso. Forse il terrorismo come minaccia globale era già in fase di riflusso prima e indipendentemente dalla guerra contro Saddam. Ma in Iraq il terrorismo non solo non demorde, ma diventa sempre più minaccioso. Ormai sono più i soldati americani morti nel «dopoguerra» che nella «guerra», ammesso che questi termini abbiano ancora un significato per una guerra non combattuta e per una pace non accettata.
I kamikaze, le autobombe, i missili mirano ora non solo ad americani e inglesi, non solo ai duecentomila uomini della polizia e dell’esercito iracheno arruolati in fretta e furia, ma alla popolazione civile sciita in quanto tale (cioè a due iracheni su tre) come dimostrano gli ultimi massacri sui pellegrini di Bagdad e di Kerbala. Se il nemico è il 65 per cento della popolazione, se i terroristi sono per metà nostalgici di un dittatore e per metà intrusi stranieri di Al Qaeda è impossibile parlare a questo punto di una qualsiasi resistenza in nome della libertà e della autodeterminazione dei popoli.
Al punto in cui siamo anche lasciare l’Iraq, lasciarlo in pace non vuol dire dargli pace. Anche se è ovvio che a riportare l’Iraq alla sicurezza e all’autogoverno dovrebbe essere l’Onu, oggi di fatto siamo nel mezzo fra il male dell’occupazione e il peggio della disintegrazione del paese.
Uniti dalla pace, divisi dall’Iraq. Le associazioni cattoliche toscane e la marcia del 20 marzo