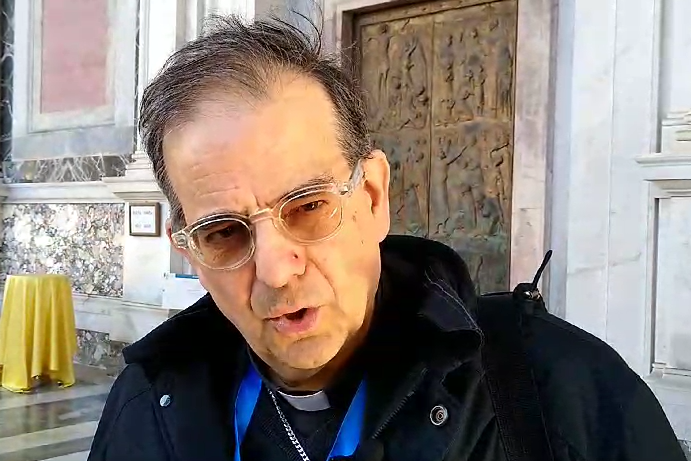Opinioni & Commenti
Iraq, la guerra che distrugge e non ricostruisce
Il rapimento è un gesto atroce che getta nell’incubo di una lotteria fra la vita e la morte il sequestrato ed i suoi familiari. Ma in questo caso è anche un pressante dilemma per il governo italiano che, al di là del dovere umanitario, è anche costretto a difendere una presenza in Iraq anche cercando di ridurre al minimo il prezzo di fronte ad un’opinione pubblica sempre più disorientata e preoccupata.
Ma se la guerra diventa anche un affare pagato in proporzione all’addestramento che si ha e al rischio che si corre è inevitabile che nasca un mercato libero di «guardie» anche al di fuori degli eserciti ufficiali. Quel che ha sorpreso in Iraq, ma che era da tempo avvertibile anche in altre aree di crisi, è stata la presenza di «un esercito» di circa ventimila persone assunte privatamente e addette a più o meno vaghi compiti di sicurezza come protezione di impianti, di convogli, di oleodotti, di personale delle multinazionali, di personaggi delle istituzioni internazionali e forse dell’attività delle stesse organizzazioni non governative.
Si tratta di gente attirata sul posto da un frullato di motivazioni in cui è difficile dire se prevalga la simpatia per una causa, lo spirito di avventura o il guadagno svelto. Sono persone il cui mestiere non è poi più discutibile di molti altri, ma che possono guadagnare anche l’equivalente di un milione di vecchie lire al giorno. La presenza di un numero così grande di stranieri dispersi sul territorio, semiclandestini ed isolati, fornisce un materiale senza fine per una industria dei sequestri come quella che purtroppo si sta organizzando in Iraq. In secondo luogo ogni iniziativa di ricostruzione del paese, di ripresa dell’attività economica, di manutenzione delle infrastrutture, di assistenza umanitaria che provenga dall’esterno è minacciato dall’insicurezza.
Infine, anche qualora queste attività proseguano, sono frenate dall’enorme lievitazione dei costi che un sistema di sicurezza così salato nei prezzi comporta. Valga ad esempio il costo della riparazione della strada KabulKandahar in Afganistan salito da 35 milioni a 300 milioni di dollari per i costi della protezione del personale. Così la guerra, finché rimane guerra, è non solo capace di distruggere, ma anche incapace di ricostruire nonostante tutte le promesse e i miraggi per il dopo guerra.