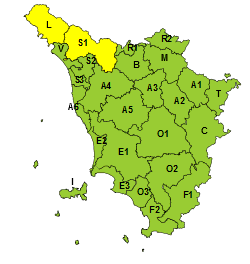Toscana
Eutanasia, dietro un «no» forte e chiaro un «sì» alla vita
L’attuale fase del dibattito bioetico nel nostro Paese è quanto mai delicata e complessa. Dopo il lungo e difficile percorso che ha accompagnato l’iter di approvazione della Legge 40 sulla fecondazione assistita ed il successivo confronto referendario, adesso è il momento della cosiddetta «bioetica di fine vita», comprendendo con questa sintesi le tematiche relative all’eutanasia, all’accanimento terapeutico, alla medicina palliativa e, più recentemente, anche al testamento biologico o dichiarazioni anticipate di trattamento.
L’Associazione «Scienza & Vita» ha voluto confermare ancora una volta, con la sua recentissima campagna di sensibilizzazione denominata «Né accanimento né eutanasia» e partita proprio da Firenze, il «no» del pensiero personalista fondato sul valore ontologico della persona umana ad ambedue le strade. Un «no», forte, chiaro e che non lascia spazio ad ambigue e fuorvianti interpretazioni. Un «no» che, proprio per essere vero e credibile, deve coraggiosamente porsi in maniera simmetrica contro entrambe quelle che appaiono sempre di più «pseudosoluzioni» della complessa questione che stiamo dibattendo: sbaglieremmo insomma se pensassimo che, pur di non rischiare un’eutanasia, potessimo indulgere ad accanirci da un punto di vista terapeutico, così come saremmo in grave errore se, viceversa, per evitare l’accanimento, propendessimo per forme larvate di eutanasia. Le risposte non possono e non devono essere queste e nemmeno un compromesso, una mediazione, una qualche forma di via di mezzo tra le due.
Accompagnare il nostro prossimo alla sua fine naturale è ben altro, è «altro» rispetto a questi due estremi: è un «sì» alla vita, un «sì» alla dignità della persona, un «sì» all’uomo. Un insegnamento ed un esempio ci vengono dalla medicina palliativa, ormai ampiamente diffusa in gran parte del nostro Paese, che ha per scopo non quello di aiutare il paziente «a morire», ma «nel morire» e quindi a vivere questa sua ultima esperienza nel modo più umano possibile. Usciamo da stupidi e talora ideologicamente alimentati equivoci e luoghi comuni: la Chiesa, almeno da Pio XII in poi, si è sempre pronunciata a favore di una medicina che riesca ad eliminare il dolore e tutti quei sintomi che possono rendere terribile l’ultimo periodo di malattia di un paziente terminale. Non ci prendiamo in giro: il fatto che nel nostro Paese l’utilizzo della morfina e dei suoi derivati sia ancora ridotto rispetto ad altre nazioni europee, non può certo essere imputato al sentire «religioso» dei medici italiani. Piuttosto le cause sono da ricercare in altre direzioni, ma sarebbe troppo lungo parlarne in questa sede.
E anche per ciò che riguarda il cosiddetto «accanimento terapeutico», termine che, per la sua ambiguità sarebbe forse da abolire, il Magistero della Chiesa, nella Dichiarazione Iura et bona, del 1980, si è pronunciata per l’eticità del non ricorso a mezzi terapeutici straordinari e della rinuncia «a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita».
Ma se le cose stanno così, allora, al di là del doveroso e serrato confronto/scontro con i sostenitori espliciti dell’eutanasia attiva, di cosa e su cosa stiamo dibattendo? I casi di Terry Schiavo, paziente in stato vegetativo, apparentemente incosciente e sottoposta ad un’alimentazione e a un’idratazione artificiali, sospese per ordine del giudice sino alla morte della ragazza e quello di Pier Giorgio Welby, malato di distrofia muscolare progressiva, cosciente, attaccato ad un ventilatore meccanico a causa della paralisi dei muscoli respiratori e che chiede, alla giustizia, una sentenza ed al parlamento una legge che gli faccia «staccare la spina», hanno qualcosa in comune? Sono casi in cui si può intravedere una componente eutanasica? A mio parere senz’altro sì nel primo esempio perché bere ed alimentarsi, sebbene artificialmente, non può configurarsi come un accanimento terapeutico bensì un naturale sostegno per un organismo umano ancora vivente, essendo lo stato vegetativo assolutamente diverso dalla morte cerebrale. Per il secondo qualcuno potrebbe opporre l’obiezione che il ventilatore si configura come terapia ed, essendo Welby cosciente, è nel suo pieno diritto rinunciare alle cure con un atto di volontà non pregressa, come nel testamento biologico, ma attuale. In poche parole: come ognuno di noi ha «diritto a non curarsi» o a interrompere cure anche salvavita, così Welby avrebbe diritto a farsi «staccare la spina».
A mio parere però, al di là del forte e voluto investimento emotivo del caso, che non fa certo bene né ad una serena riflessione bioetica, né ad un altrettanto sereno pronunciamento dei giudici, né tantomento ad un attento e scrupoloso dibattito parlamentare, il caso Welby si differenzia dal semplice diritto a non curarsi o ad interrompere le cure e ciò almeno per due motivi: il primo è costituito dal fatto che lo staccare il ventilatore comporterebbe in maniera molto veloce e diretta la morte della persona ed è difficile distinguere questa dinamica da un’eutanasia attiva; il secondo è legato al fatto che, inevitabilmente, Welby avrebbe bisogno di un intervento esterno per staccare la spina (medico, infermiere, parente, amico) e tutto ciò comporta l’intervento di un’altra coscienza, di un’altra volontà, di un’altra soggettività che viene coinvolta. Insomma, la scelta non interessa più soltanto l’individuo sofferente, ma va ben oltre il medesimo.
Pur con le dovute differenze, legate alle specifiche sensibilità, una cosa senz’altro accomuna ed intimamente unisce il pontificato di Benedetto XVI con quello di Giovanni Paolo II: l’intuizione quasi profetica in tempi non recenti e la successiva convinzione che, sulle tematiche della difesa della vita e della bioetica, si gioca il futuro della nostra stessa democrazia. Scrive Giovanni Paolo II nell’Enciclica Evangelium Vitae: «Il valore della democrazia sta o cade con i valori che essa incarna e promuove», tra i quali lo scomparso Pontefice annovera la dignità di ogni persona umana ed il rispetto dei suoi diritti intangibili e inalienabili. Senza questi valori, scrive ancora Giovanni Paolo, «lo stesso ordinamento democratico sarebbe scosso nelle sue fondamenta, riducendosi a un puro meccanismo di regolazione empirica dei diversi e contrapposti interessi». Addirittura, prosegue poi, negli stessi regimi fondati sulla partecipazione democratica, «la regolazione degli interessi avviene spesso a vantaggio dei più forti, essendo essi i più capaci di manovrare non soltanto le leve del potere, ma anche la formazione del consenso. In una tale situazione, la democrazia diventa facilmente una parola vuota».
Affermazioni gravi queste, ma profondamente vere. In sintesi, ci vuol dire il Papa, laddove prevale il relativismo etico, laddove non esiste una verità sull’uomo e per l’uomo riconosciuta come tale e valida in ogni tempo e ad ogni latitudine, la conseguenza più naturale è costituita dallo sterile rifugiarsi in un triste individualismo fatto di egoistica rassegnazione ed insieme di rifiuto ed emarginazione del più debole, di colui che può essere di disturbo o di inciampo ad una pretesa «qualità di vita»: si tratti del disabile, del malato terminale, dell’embrione non voluto, dell’immigrato che sbarca sulle coste italiane in cerca di fortuna e di libertà. Un individualismo che può sfociare in una deriva solipsistica (pensiamo a certe forme estreme del pensiero esistenzialista) che vede gli altri, il nostro prossimo, non come «amico morale», ma come «straniero morale», qualcosa o qualcuno che mi è costituzionalmente estraneo.
Ma allora, se questa è la situazione, l’unico modo per non cedere all’«homo homini lupus» è, a parere di qualcuno, quello di ricorrere ad una visione «contrattualistica» della convivenza umana e civile. Se ognuno di noi è straniero morale per l’altro l’unica risposta è un rinnovato contratto sociale. Purtroppo la tragica conseguenza di tutto questo è che, quando ogni rapporto, anche il più intimo, il più naturale (pensiamo ad esempio al rapporto madre/padre – figli), è ridotto ad una forma contrattuale, si arriva a snaturare il fondamento stesso di ciò che, per sua indole, deve svilupparsi nel segno della gratuità, del dono, del reciproco incontro. E, se tutto è ridotto a contratto, va da sé che chi ha meno potere contrattuale da mettere sul tavolo della vita, ad esempio i più deboli visti in precedenza, sia destinato a soccombere a vantaggio dei forti.
Insomma, per concludere, non dimentichiamoci che dietro tante manifestazioni di solidarietà e compassione possono nascondersi ben altri interessi, come quelli di avviare, in un momento in cui la cronicità sta divenendo protagonista del panorama patologico dei Paesi occidentali, un progressivo e subdolo razionamento delle risorse che, ben diversamente da un’auspicabile razionalizzazione, inizi proprio tagliando fondi da coloro che «pesano» di più, in termini di costi, sul sistema: guarda caso i soggetti più fragili, ad iniziare dai malati terminali. Troppo spesso ci dimentichiamo che, con tutte le sue pecche, il nostro Servizio sanitario pubblico costituisce una grande conquista di solidarietà che ben pochi Paesi possono vantare, ad iniziare da quei Paesi Bassi in cui si è legalizzata l’eutanasia, anche per i minori (sic!) e dove si assiste ad una terribile deriva che ben poco ha a che fare con la tanto sbandierata «pietà», ma che invece sa di morte, di solitudine, di chiusura egoistica all’altro.
Testamento biologico, una materia delicata
BENEDETTO XVI: MESSAGGIO PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2007
GIORNATA PACE 2007: CARD. MARTINO, «LA PERSONA E LA PACE SI RICHIAMANO IN UNA FECONDA CIRCOLARITÀ»