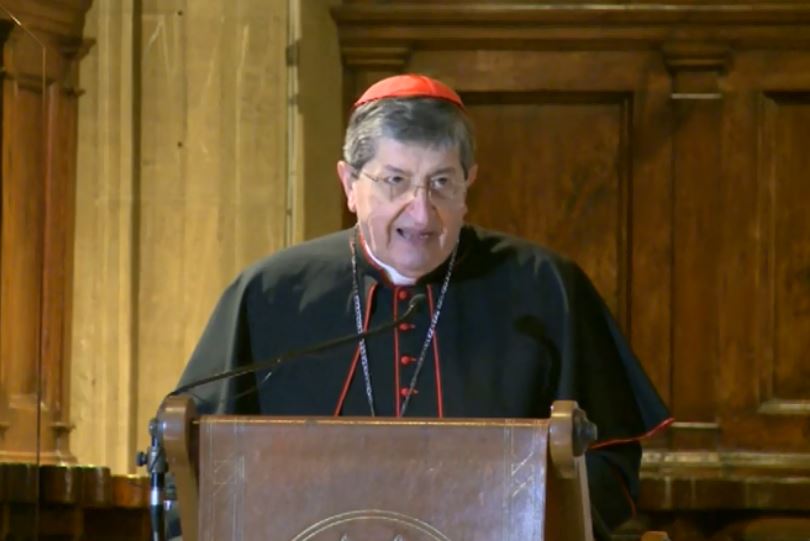Opinioni & Commenti
Barletta, morti bianche figlie del lavoro nero
di Romanello Cantini
Non importa arrivare fino a Pechino per trovarsi in Cina. Basta fermarsi a Barletta. Anche lì si può lavorare fino a quattordici ore al giorno guadagnando meno di quattro euro all’ora. E certamente le quattro operaie, che sono morte sotto le macerie in uno di quei laboratori con poco spazio per non muoversi dal lavoro e tanto neon per infilare i punti e che tante volte abbiamo visto nel nostro paese, sono tutt’altro che l’eccezione.
Le statistiche fanno salire a tre milioni i lavoratori in nero in Italia accompagnati da quei mille morti sul lavoro ogni anno che in buona parte sono attribuibili a lavori dove le regole non c’entrano dentro. Solo che questa volta a Barletta l’eccezione è apparsa ormai regola. Il laboratorio, per chi gli voleva dare un’occhiata, era distante dal Comune cinquanta metri. I vigili ci avevano fatto capolino senza vedere nulla. Il sindaco (pd) e un consigliere regionale hanno in sostanza difeso il lavoro nero in Puglia come unica possibilità. Meglio nero che invisibile, come si diceva una volta quando ad essere nero era il pane oltre che il lavoro. Mariella, l’unica operaia tirata fuori viva dalle macerie, dopo avere passato dodici ore in compagnia della morte, ha detto che era stata lei a non volere essere regolarizzata ed ora aveva solo paura di non trovare più lavoro. In questo senso il lavoro nero di Barletta, con il suo ventesimo di italiani che lo praticano, è davvero Terzo Mondo non solo nel fare, ma anche nel dire. Quello stanzone è anzi la globalizzazione. Quando negli anni passati le organizzazioni internazionali hanno cercato di introdurre delle regole minime nel lavoro dell’Asia, dell’Africa, nell’America latina si sono sentite rispondere che così si volevano rovinare i lavoratori di questi paesi che del resto erano ben disposti a lavorare a quelle condizioni.
Centoventi anni fa, in un periodo in cui il contratto di lavoro era così sacro che persino lo sciopero era punito perché veniva meno a quell’accordo, fu addirittura la Rerum novarum a rompere questo tabù e a denunciare che perfino un lavoro accettato dal lavoratore era illegittimo a certe condizioni. Di fronte a chi sosteneva che il tipo di lavoro «lo delibera il consenso delle parti» Leone XIII scrisse: «Neanche di sua libera elezione potrebbe l’uomo rinunziare ad essere trattato secondo la sua natura ed accettare la schiavitù, perché non si tratta di diritti dei quali sia libero l’esercizio, bensì di doveri verso Dio assolutamente inviolabile». Detto in altri termini, fuori del tono solenne proprio dello stile dell’epoca, l’uomo può venire a patti fino a che non cessa di essere uomo. E se questa è una fondamentale dichiarazione di principio spetta ai politici cercare il più possibile di farla rispettare attraverso interventi realistici ma efficaci.
È generalmente riconosciuto che il contrasto nei confronti del lavoro nero è rappresentato soprattutto da una indennità generale di disoccupazione o, come altrimenti si chiama, da un salario minimo garantito che permetta a chiunque di non vendersi al di sotto di una certa cifra. Paesi agli antipodi da noi come l’Australia e la Nuova Zelanda hanno deciso questa copertura minima di tutti i loro cittadini addirittura al tempo della Rerum Novarum. Praticamente quasi tutti i governi europei l’hanno adottata negli ultimi cinquanta anni. La Francia è il paese più generoso dove il salario minimo, in determinate situazioni familiari, può arrivare fino ai mille euro al mese. Ma fino a circa la metà di questa cifra ci può arrivare anche in Gran Bretagna, in Spagna e negli Stati Uniti. L’Italia è quasi sola in Europa a non avere una assicurazione generalizzata di disoccupazione che sia rivolta anche al giovane in cerca di prima occupazione e all’adulto da anni disoccupato. Non si tratta, soprattutto in questo periodo di vacche magre, di rispondere facilmente che ci mancano le risorse. Quando gli altri paesi stabilivano il salario minimo noi abbiamo semplicemente distribuito male le nostre risorse. Le abbiamo profuse sulle pensioni, anche a cinquanta anni, senza dare una lira al giovane disoccupato di vent’anni. E in Europa ancora oggi nelle statistiche siamo primi nella spesa per le pensioni e ultimi nella spesa per la disoccupazione, come del resto nella spesa per la famiglia, l’altro grande intervento che aiuta soprattutto i ceti più poveri.