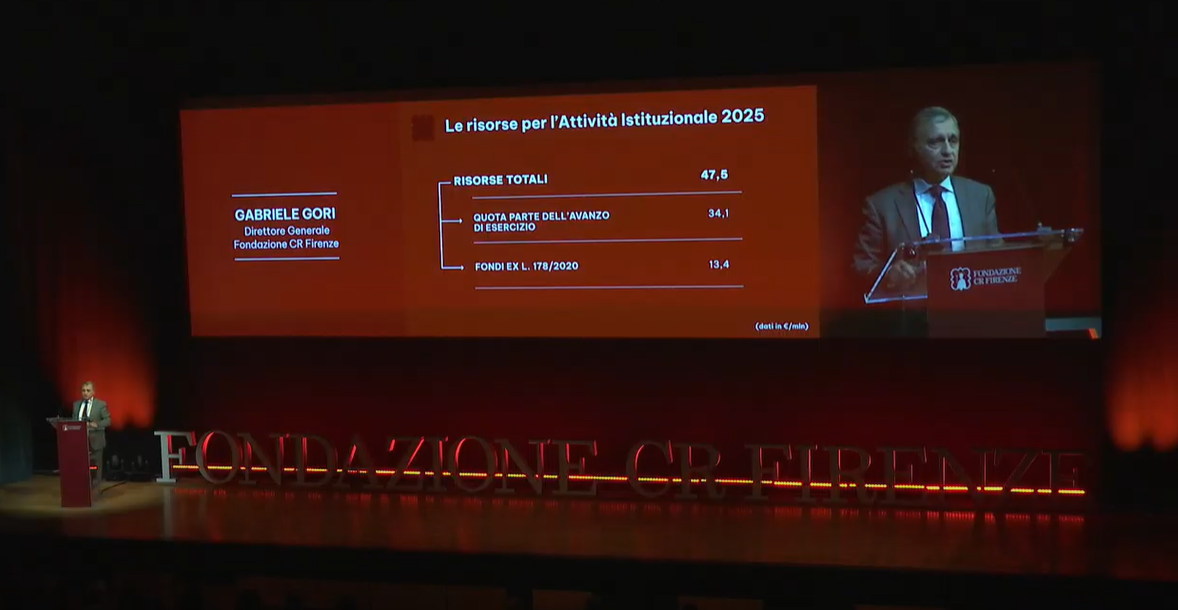Opinioni & Commenti
A che serve far fuori Arafat?
Del resto Sharon dovrebbe ricordarsi perché fu invaso il Libano nel 1982, visto che fu protagonista di quella vicenda (e purtroppo ci fu anche il massacro di Sabra e Chatila): il Libano fu invaso all’indomani di dichiarazioni dell’allora segretario di stato Kissinger su un piano Reagan per l’autonomia palestinese, considerata a Washington disse Kissinger una sorta di crisalide di uno stato sovrano vero e proprio.
La prima vittima dell’invasione del Libano fu appunto questo piano americano.
Mettere delle condizioni alla trattativa significa non aprire la trattativa. Ed anche se questo non si vorrebbe, significherebbe pur sempre affidare la trattativa alle mani poco affidabili degli estremisti. Ha fatto notare di recente Andreotti che le due parti dovrebbero saper aprire, e proseguire un negoziato tappandosi le orecchie per non farsi condizionare dagli estremisti al lavoro.
La tregua prima del negoziato si è rivelata infatti un antidoto al negoziato. Che serve comunque, in questa condizione, puntare il dito contro Arafat scambiandolo frettolosamente e per comodità, come il Bin Laden del Medio Oriente, pericoloso tanto per gli israeliani quanto per l’occidente? Arafat come Bin Laden significa ridurre poco giudiziosamente il Medio Oriente ad un capitolo della guerra intrapresa da Bush e dagli europei, con soldati o meno sul terreno. Contro il terrorismo che oggi ha il volto dei talebani dovrà guardarsene non solo Bush ma anche gli europei e gli stessi governi arabi che pensiamo magari obtorto collo, si sono schierati nella guerra contro i talebani.
Basterà, dopo tutto, chiedersi se sbarazzarsi di Arafat agevoli la pace. Neppure il più malaccorto degli analisti potrebbe rispondere affermativamente. È invece un fatto che la strategia israeliana, specie con il ritorno al potere del partito di destra, il Likud, punta neppur troppo di nascosto a mantenere le annessioni fatte, (il Golan dove c’è l’acqua, bene prezioso da quelle parti) e a mollare eventualmente ai palestinesi solo piccole parti dei territori occupati. Le decisione dell’Onu aspettano qui di essere riconosciute da 34 anni da quando, dopo la guerra dei sei giorni e l’occupazione della Cisgiordania furono solennemente emesse. E una ragione deve pur esserci. È difficile pensare infatti a concessioni di peso quando recentemente, ad esempio, Sharon ha invitato, parlando a Mosca, gli ebrei russi a raggiungere Israele. Ora Israele e la Palestina sono già dei condomini ristretti. Anche i laburisti si sono sempre detti ad esempio contrari al rientro dei profughi palestinesi costretti a lasciare le loro case, nel ’48 e negli anni successivi, verso i campi profughi della Giordania e della Siria, perché il posto è quello che è e tutti gli aventi diritto non c’entrano.
Sette giorni, o anche uno solo, senza incidenti sono ostacoli alla trattativa, così come il rifiuto di osservatori e magari di forze di interposizione delle Nazioni Unite non aiuta la realizzazione di una tregua. La condizione prima per la pace è che ci siano due stati con confini internazionalmente garantiti, ma questo obiettivo non lo raggiunge certo Sharon se continuerà a voler fare da solo e neppure Arafat, anello più debole, oggi, della catena mediorientale.
Israele è certamente uno stato democratico, dove i governi vengono scelti dai cittadini, ma non sempre i governi, per essere democratici, debbono assecondare opinioni pubbliche che giudichino praticabili solo le scorciatoie. Prendersela con Arafat sembra oggi più di una scorciatoia: volenti o nolenti è un regalo in più fatto agli estremisti e di doni agli estremisti, purtroppo, è lastricata la storia del Medio Oriente, dal ’48 in poi.