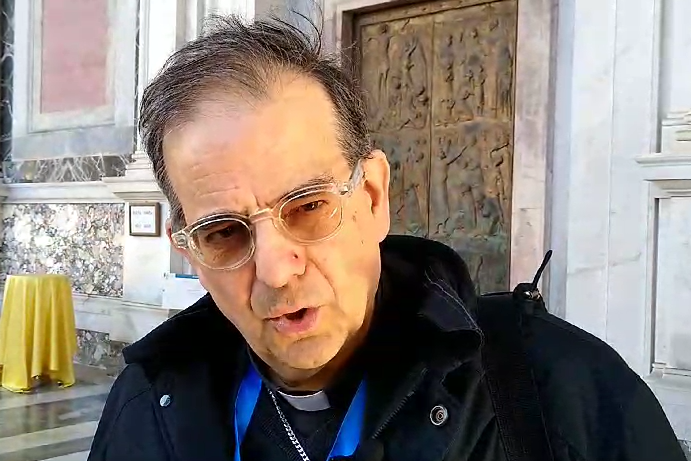Opinioni & Commenti
Abbonamento Rai, bugia che continua
Andiamo per ordine. Ciascuno di noi ha ricevuto per posta una lettera dall’Agenzia Entrate. La firma tale Fernanda Maocci, direttore dello sportello «abbonamenti tv». In allegato c’è un bollettino postale già predisposto per il pagamento di 97,10 euro. Fra parentesi: 3,5 euro in più rispetto all’anno scorso.
Sempre su internet si scopre che la norma giuridica alla base del canone risale addirittura al 1938: 65 anni fa, quando c’era solo la radio. La televisione sarebbe arrivata una dozzina di anni dopo a quel RDL 21 febbraio 1938 n. 246 che, appunto, disciplinava gli abbonamenti alle radioaudizioni. La erre significa «regio»: normale 65 anni fa, quando ancora la Repubblica non c’era e Benito Mussolini aveva a che fare con l’antenato di quel ragazzotto oggi impegnato a vendere sottaceti. Magari reali, ma pur sempre sottaceti.
Di sicuro tutto sarà in regola sotto il profilo giuridico, però fa un certo effetto scoprire che la tv pubblica, alla vigilia del digitale, continua a basare il suo canone su una norma scritta quando ancora la tv non c’era.
Ma andiamo ancora avanti. Scopriamo un aspetto certo noto agli esperti di diritto ma forse ignoto alla maggioranza dei cittadini.
Pochi mesi fa (sentenza 284 del giugno 2002) la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del decreto «regio»: qualcuno (il Tribunale di Milano) aveva infatti promosso un giudizio di legittimità costituzionale fondato sulla possibile «irragionevolezza» delle attribuzione alla sola Rai dei proventi del canone. In altri termini: se il canone è solo una imposta per il possesso degli apparecchi televisivi (dai quali, come ovvio, non si vede solo la Rai), non si comprende perché quei soldi debbano andare alla sola azienda pubblica.
La Corte ha dato ragione alla Rai, ma è istruttivo leggere la sentenza. Il canone, infatti, è giustificato solo con l’obbligo Rai di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici nonché di curare la specifica funzione di promozione culturale e l’apertura dei programmi alle più significative realtà culturali.
Parole chiare anche quelle successive, riferite all’obbligo Rai di adeguare la tipologia e la qualità della propria programmazione alle specifiche finalità del servizio, non piegandole alle sole esigenze quantitative dell’ascolto e della raccolta pubblicitaria e non omologando le proprie scelte a quelle proprie dei privati.
Parole da tenere a mente proprio in questi giorni, quando stiamo pagando un canone che finisce quasi tutto alla Rai (tranne una piccola quota che va e chi lo sapeva? all’Accademia di Santa Cecilia).
Se il legislatore ha scelto di imporre ai cittadini una imposta destinata a finanziare una buona parte del servizio pubblico radiotelevisivo, i cittadini non hanno solo il dovere di pagare ma pure il diritto di non avere programmi omologati, verso il basso, alle reti commerciali.
Non resta che una domanda, a cui ovviamente ciascuno è libero di rispondere come crede: con un cda dimezzato e in sostanziale illegittimità istituzionale, con i programmi che tutti conosciamo (alcuni di ottimo livello ma altri, francamente, impresentabili), con una avvilente tendenza al taroccamento e al cattivo gusto, con una informazione sempre meno significativa o strumentale non verso il diritto del cittadino a conoscere ma verso l’interesse di chi comanda a non essere disturbato, la Rai di oggi merita davvero i nostri 97,10 euro?