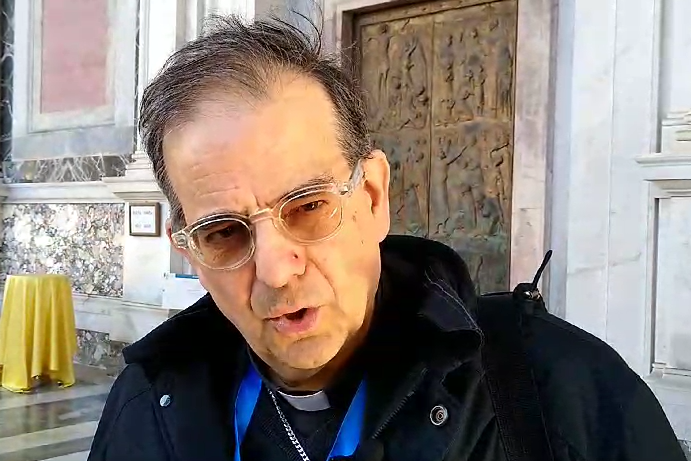Opinioni & Commenti
L’impresa ha bisogno di controlli dall’alto, dal basso e dall’interno
All’origine dei numerosi scandali finanziari c’è una rivoluzione culturale e politica iniziata negli anni settanta. Nel 1970 Milton Friedman, caposcuola dei liberisti americani, scriveva che l’impresa ha un solo dovere sociale: massimizzare il profitto dei suoi azionisti. Nel 1975 a Rambouillet, presso Parigi, i Sei Paesi maggiormente sviluppati (G6) concordarono una serie di misure che in poco tempo avrebbero portato alla privatizzazione di grandi imprese pubbliche e all’apertura e integrazione dei mercati nazionali, inclusi quelli finanziari. Si riteneva che la concorrenza avrebbe accresciuto l’efficienza economica, migliorando l’allocazione delle risorse esistenti. In particolare, l’internazionalizzazione dei mercati finanziari avrebbe permesso ai risparmiatori di scegliere gli investimenti più redditizi e alle imprese di crescere attingendo a nuovi e più consistenti flussi di capitale.
Il diritto si è adeguato alle esigenze dell’economia. I mercati, per funzionare bene, hanno bisogno soprattutto di trasparenza. E’ necessario che coloro che vi operano imprese, risparmiatori, consumatori possano disporre delle informazioni necessarie per scegliere in modo razionale. La prima e fondamentale informazione riguarda i bilanci delle imprese. Per garantirla i maggiori paesi hanno codificato una serie di norme, la cosiddetta corporate governance o governo delle imprese, che prevede una sequenza di controlli: i bilanci devono essere redatti secondo particolari regole, sottoscritti dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale e certificati da società di revisione esterne all’impresa. Si tratta di un controllo prevalentemente privatistico, secondo una logica che mira a ridurre l’intrusione di soggetti pubblici nella sfera degli affari.
Le premesse del crack si manifestano negli anni novanta. L’impresa, intesa come un’organizzazione finalizzata a massimizzare il profitto dei suoi azionisti, non regge alla pressione dei mercati finanziari, che rompe le fragili paratie del diritto societario: un voto inferiore di una società di rating, una flessione nei conti trimestrali, una valutazione negativa di qualche analista rischiano di far precipitare le quotazioni di borsa e di allontanare ingenti capitali. E’ possibile che l’imprenditore avverta la tentazione di manipolare i bilanci. La legge serve anche a reprimere quelle pulsioni. Ma la corporate governance evidenzia un clamoroso conflitto di interesse, che Guido Rossi ha definito epidemico. A tutti i livelli i controllori dipendono dai controllati: i consiglieri di amministrazione e i sindaci revisori sono nominati e retribuiti dalla proprietà, le società di revisione, oltre ad essere scelte e remunerate dalla proprietà, spesso svolgono attività di consulenza all’impresa sottoposta a controllo. Non è difficile immaginare come l’imprenditore mosso da una pura logica di profitto e sottoposto al pressante giudizio dei mercati finanziari, possa aver ceduto alla tentazione di falsificare i bilanci.
In Italia il caso Parmalat ha aperto un dibattito che si preannuncia lungo e tormentato. Si ipotizza un sistema di controlli a tenaglia. Dall’alto con la ridistribuzione delle competenze tra due autorità gemelle (le cosiddette twin peaks) incaricate di vigilare, una, sulla stabilità delle banche (e quindi dei depositi) e l’altra sulla trasparenza dei mercati finanziari. Dal basso con una revisione del diritto societario che elimini o riduca i conflitti di interesse: per esempio prevedendo che la maggioranza dei sindaci revisori sia nominata dagli azionisti di minoranza e che questi siano rappresentati anche nel consiglio di amministrazione.
Si tratta di proposte condivisibili e di sicura efficacia. La sensazione, però, è che si consideri ancora l’impresa soltanto una organizzazione privatistica a servizio dei soli azionisti. La vicenda Parmalat dimostra invece che la grande impresa è sempre di più una istituzione che coinvolge numerosi soggetti (stakeholders): dai lavoratori, ai risparmiatori, alle comunità locali nelle quali è ubicata. E’ sempre di più una comunità di lavoro e di interessi. La Chiesa, proprio per rafforzare la cooperazione tra capitale e lavoro, ha perorato la soluzione della partecipazione degli operai alla gestione e/o agli utili dell’impresa.
Il principio è stato recepito dalla Costituzione italiana che all’art. 46 riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”. L’articolo fu ideato da Amintore Fanfani. Nel dibattito parlamentare alcuni deputati proposero di aggiungere anche la partecipazione agli utili delle imprese ma l’Assemblea Costituente decise di non introdurre vincoli stringenti lasciando al futuro legislatore la libertà di stabilire le modalità e le forme di quella partecipazione. L’art. 46, come è noto, è rimasto inattuato. Oggi non si tratta certo di rispolverare vecchi miti della cogestione o dell’operaismo. Si tratta piuttosto di verificare se è possibile coinvolgere maggiormente i lavoratori nella gestione delle imprese. Il sistema dei controlli, dall’alto e dal basso, verrebbe così rafforzato da un controllo interno all’impresa stessa, esercitato congiuntamente dai due principali protagonisti di queste particolari comunità di lavoro e di interessi: gli azionisti e i lavoratori.