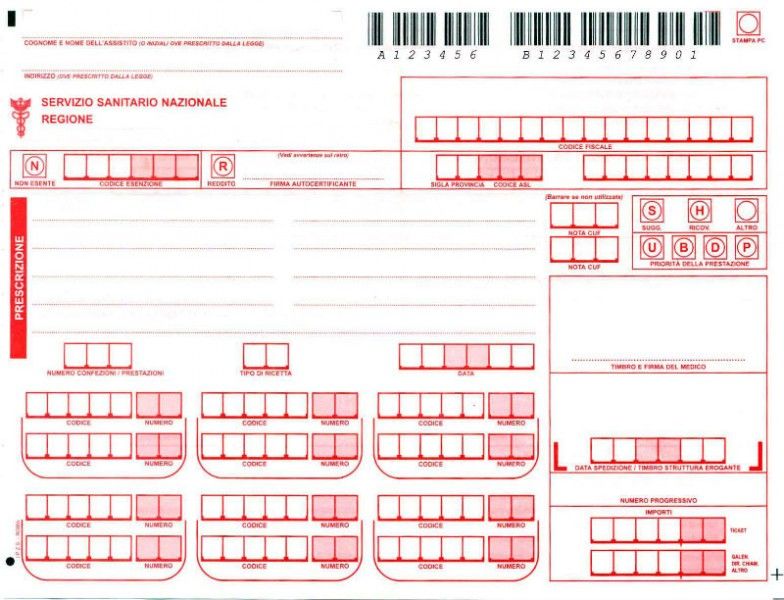Opinioni & Commenti
Afghanistan, prove di democrazia
Le elezioni afghane di sabato scorso non ci danno ancora una risposta definitiva sul futuro del Paese e sulla scommessa di una possibile vera democrazia. Si è votato, tuttavia, nella calma e con un’alta partecipazione. Il salto sembra evidente soprattutto per la presenza femminile. Ma, al di là degli allarmi sui brogli, quel che colpisce è che ancora in questo Paese, in cui ci sono dovunque più armi che frigoriferi, si sia votato non in termini individuali, ma comunitari secondo l’appartenenza al clan o alla tribù. La libertà dell’Afghanistan è insomma la libertà dei comuni medioevali dove i Montecchi votavano per i Montecchi e i Capuleti votavano per i Capuleti. Prima ancora del consolidamento della democrazia manca la creazione di uno Stato, anche se si sprecano le nazioni con le armi al piede secondo la decina di etnie che sole hanno avuto finora in Afghanistan una identità e un potere reale.
La presenza di uno Stato islamico in Europa non è di per sé una contraddizione. Altri Stati a maggioranza musulmana che domani potrebbero chiedere l’adesione (Albania, Bosnia) stanno già nel cuore geografico del Vecchio continente. L’identità europea, sarebbe stata meglio difesa, anche come assicurazione che ci avrebbe permesso di accogliere tranquilli altre adesioni, se nella Carta costituente ci fosse stato un riferimento più preciso alle nostre radici religiose.
E per quanto riguarda la Turchia (ad evitare fra l’altro il paradosso di un Paese europeo che unico avrebbe una religione dominante al 99,08% dei suoi abitanti) oltre a chiedere democrazia, diritti umani, parità fra uomo e donna, non è superfluo un richiamo alla libertà religiosa. La Turchia moderna ha un debito verso i cristiani armeni e greci che furono cacciati mentre procedeva quel processo di occidentalizzazione del Paese i cui meriti ci hanno fatto dimenticare che all’inizio del secolo scorso metà della popolazione di Istanbul era cristiana.
Il quadro dei Paesi islamici in movimento si allarga con il terribile attentato di Taba. Dopo la strage di settanta turisti europei a Luxor di sette anni fa, ora l’Egitto è di nuovo chiamato a fare i conti con una minaccia che mira nel mucchio allo straniero chiunque sia e che rischia di prosciugare quella risorsa del turismo così importante per un Paese dove solo un abitante su tre ha un lavoro. La nuova sfida mette in discussione la capacità del governo Mubarak di prevenire e reprimere il terrorismo. Ma interpella anche tutta la società civile egiziana a cominciare dall’Università di Al Azhar al Cairo, così autorevole nel mondo musulmano, così ascoltata sia che decida di sostenere il fanatismo, sia che indichi al contrario la via del dialogo e della pace nella giustizia.