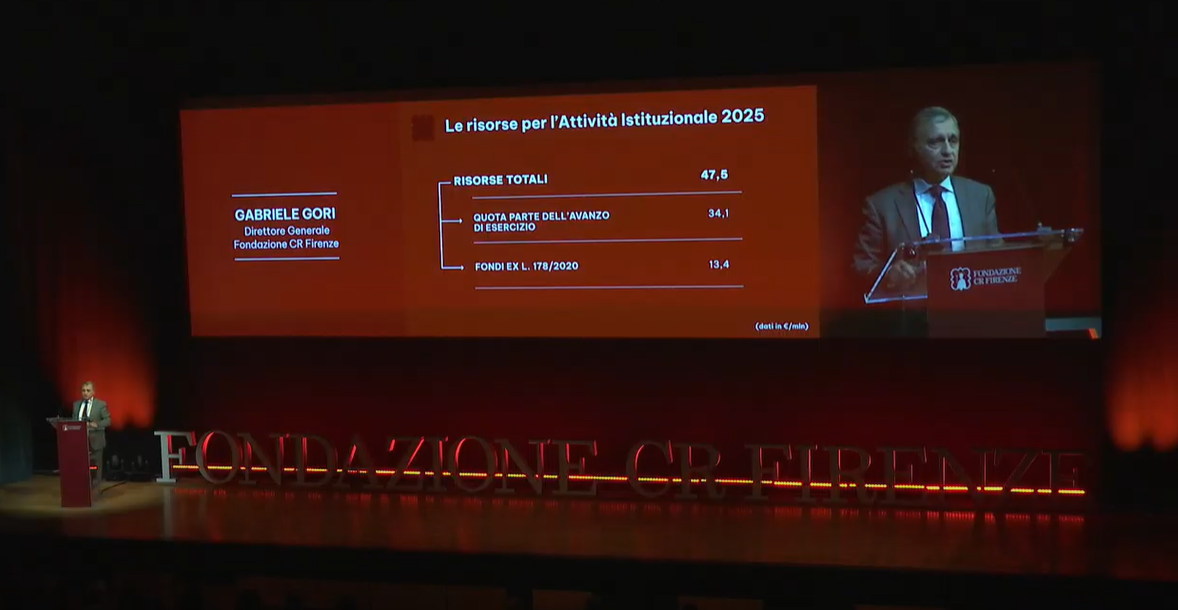Opinioni & Commenti
L’anno giudiziario e i mali della giustizia
di Umberto Santarelli
Questa volta l’inaugurazione dell’Anno giudiziario ha corso il rischio (o, forse, ha avuto l’occasione preziosa) di trasformarsi da cerimonia solenne, nella quale politici giudici e avvocati si scambiano cortesie scontate, in una disputa vera sui mali della nostra Giustizia, sulle responsabilità da riconoscere e sui rimedî da adottare.
Si sapeva già da prima che, mentre in Cassazione tutto si sarebbe svolto nella forma consueta (forse per un riguardo alla presenza delle massime cariche dello Stato), il giorno dopo nelle Corti d’appello i Presidenti e i Procuratori generali avrebbero svolto (come sempre) le loro relazioni, mentre gli altri magistrati si sarebbero presentati con la toga nera delle udienze ordinarie (in luogo di quella rossa riservata alle occasioni solenni), avrebbero tutti portato con sé ben visibile una copia della Costituzione, e soprattutto avrebbero abbandonato l’aula nel momento in cui doveva prender la parola il rappresentante del Governo; e tutto questo avrebbero fatto per dimostrare il loro profondo dissenso da scelte di politica legislativa che ritengono destinate non a tutelare il bene pubblico ma a prestare un indebito soccorso a interessi personali immeritevoli di qualunque protezione da parte dello Stato.
Le cose son andate secondo le previsioni. Naturalmente sulle adesioni a questa «protesta» silenziosa le stime numeriche sono state (parzialmente almeno) discordanti; ma nessuno ha potuto negare che la differenza dalle inaugurazioni degli anni passati fosse evidentissima. Insomma, non s’è trattato certamente d’una cosuccia da poco che si possa far finta di dimenticare: per convincersene bastava dare una scorsa ai giornali del giorno dopo.
Il messaggio dell’Associazione Nazionale dei Magistrati era perfettamente leggibile: si voleva affermare che certe regole «nuove» in materia di processo penale, che una coalizione politica disposta a profittare indebitamente della maggioranza di cui dispone vorrebbe imporre, son del tutto inaccettabili perché contravvengono a regole e principî chiaramente scritti nella Costituzione.
E difatti, in Cassazione (dove in verità nessuna protesta era prevista), il Ministro della Giustizia ha replicato con grande durezza (anche formale) a questo messaggio, dicendo due cose piuttosto mal assortite tra loro: a) che tutti dobbiamo aver rispetto per l’opera dei giudici, chiamati ad essere interpreti scrupolosi e assolutamente trasparenti della Legge; b) che il Parlamento è sovrano quando formula i precetti legislativi e che ai giudici spetta soltanto di applicare con diligenza questi precetti ai fatti sui quali son chiamati a decidere.
L’on. Alfano, che a differenza di qualche suo recente predecessore è un giurista di professione, sa certamente che da un pezzo in Europa quasi nessuno crede più a quel vecchio mito «napoleonico», a stare al quale nelle leggi c’è scritto tutto e il giudice deve solamente leggerle con attenzione e applicarle a modino, contentandosi così di farsi loro «viva voce». Anche perché al di sopra della legge ordinaria c’è la Costituzione, che il legislatore deve osservare con scrupolo se non vuol che la Corte costituzionale cancelli inappellabilmente quanto sia stato scritto troppo di furia (magari per motivi sottaciuti, ma evidenti che non hanno molto a che fare con un esercizio corretto del potere legislativo).
Ragionando di mitologie giuridiche della modernità, qualcuno ha scritto che «l’uomo della strada ha ragione di diffidare: se il diritto è legge, e se legge è soltanto un comando astratto dai contenuti indiscutibili, pensato e voluto nel lontano olimpo dei palazzi romani del potere, la sua identificazione con un fulmine che piove sulla testa di malcapitati non è poi tanto peregrina».