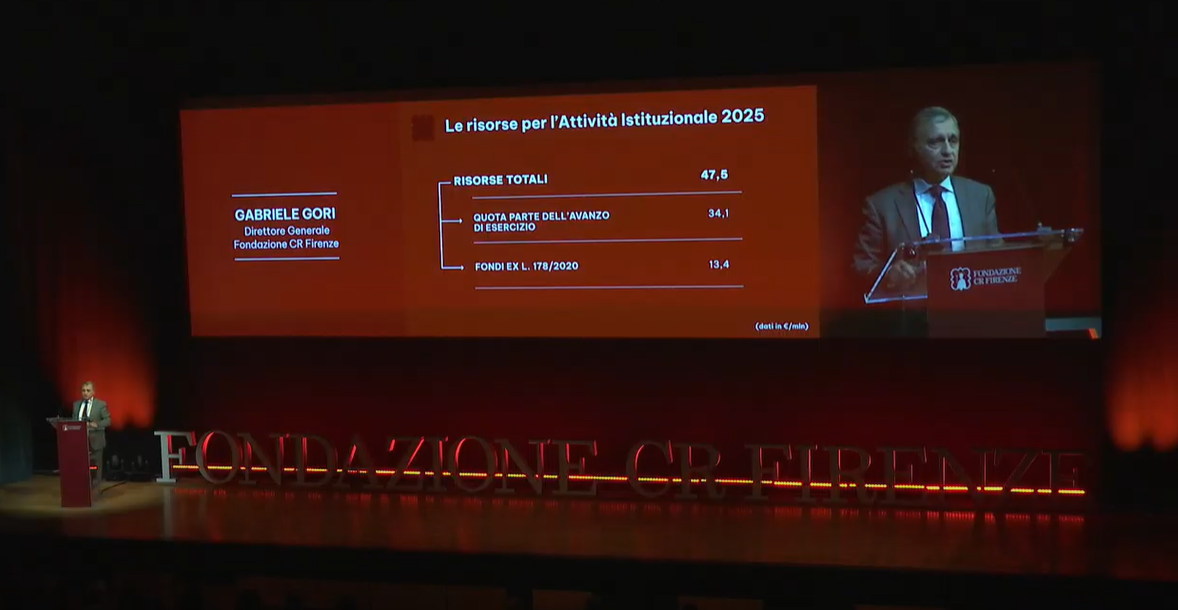Cultura & Società
Riccardo Muti: «Il podio? Un’isola di sofferenza»

di Francesco Giannoni
Quando ero bambino mio padre mi chiese se fossi voluto andare con lui al Comunale a sentire l’ouverture della Scala di Seta di Rossini: «C’è un giovane maestro, si chiama Riccardo Muti, e quando dirige si agita molto: vedrai, ti piacerà». Rossini era il primo pezzo, e il giovane maestro non deluse le aspettative e si agitò moltissimo, con quei capelli che andavano dappertutto. Alla fine dell’ouverture chiesi a mio padre di riportarmi a casa, tanto «tutto il resto non lo conosco ». Senza batter ciglio, acconsentì perdendo «tutto il resto»: il quarto concerto di Beethoven, la Suite dalla Turandot di Busoni e l’Oiseau de Feu di Stravinskij: un concertone da saltare sulla poltroncina.
Alcuni decenni dopo Muti, dopo una prova con l’orchestra del Maggio, mi riceve nel suo camerino. Con la sua voce morbida e bassa, dal caldo accento partenopeo, si scusa per le difficoltà incontrate nell’organizzare l’intervista, ma «gli ultimi due anni sono stati per me un inferno». Cominciamo dal 17 giugno quando, al Ravenna Festival, Muti diresse la Banda di Delianuova.
Dopo questo concerto, lei ha sostenuto l’importanza delle bande. Ci può parlare della sua simpatia per queste compagini musicali?
«Più che di simpatia parlerei di ammirazione, rispetto e gratitudine. Nell”800 e per gran parte del ‘900, in un’Italia che ha privilegiato tante cose ma non la musica (infatti la maggior parte dei teatri è chiusa), le bande sono state il veicolo più importante per la diffusione della musica: a feste patronali, processioni, cerimonie funebri hanno portato al popolo fantasie musicali sulle opere, sul repertorio sinfonico o religioso. Prima ho provato lo Stabat Mater di Rossini. Ancora oggi, quando in Puglia vedo le processioni del Venerdì Santo e del Sabato Santo, uno dei pezzi che la banda suona è proprio tale partitura. Io, che ho visto un’orchestra per la prima volta a 16 anni perché in Puglia non ce n’erano, mi sono avvicinato alla musica non solo attraverso il violino e il pianoforte che studiavo privatamente, ma anche ascoltando le bande. Appena ho saputo della banda di Delianuova, vista la sua qualità, ho deciso di dirigerla a Ravenna per significare l’importanza che le bande ancora hanno: danno lavoro a strumentisti che in altro modo non lo avrebbero perché mancano le orchestre, e nutrono una cultura musicale che è affinamento e ingentilimento dell’anima. Tant’è vero che uno dei ragazzi di Delianuova, intervistato, ha detto con estrema semplicità: mi hanno messo in mano questo strumento e così mi hanno tolto dalla strada».
Nell’ultimo Maggio durante la sinfonia di Haydn sembrava che lei, con quella musica giocosa e gioiosa, si divertisse molto.
«Che io mi diverta, è una sensazione sbagliata. L’esecuzione, anche di una musica brillante, per me non è mai divertimento. Non capisco i colleghi che dicono sono sul podio e mi diverto. Per me il podio è un’isola di grande impegno e anche di grande sofferenza. Evidentemente c’erano nella musica leggerezza, vivacità e giovialità che cercavo di evocare dagli strumentisti anche con l’espressione; oppure in alcuni momenti ero così contento di come l’orchestra suonava che le trasmettevo la mia felicità. Ma il direttore non deve vivere anche la musica più giocosa e gioiosa come un divertimento; diceva De Filippo: l’interprete deve controllare ciò che sta creando. Un attore in un momento tragico del dramma può destare il senso del pianto nel pubblico ma non può piangere in scena, deve sempre controllare la situazione».
Dopo l’ultimo concerto a Firenze lei, parlando al pubblico, citò la battuta di un contrabbassista del Maggio, chiamandolo «mio collega». Qual è il rapporto fra direttore e orchestrali, quello di un primus inter pares o di un leader?
«Il direttore deve trasmettere a 100 musicisti una chiara idea interpretativa dei brani da eseguire; per far questo deve essere convincente. Quindi bisogna che sia un leader, come gli inglesi intendono il verbo to lead, e deve guidare gli altri. Non si dirige l’orchestra chiedendo le opinioni dei vari musicisti. Ma un vero direttore è quello che, se ci sono in partitura grandi passi solistici per uno degli strumenti dell’orchestra, deve dare la possibilità al suo collega (con-cui-lega, con cui lavora) di esprimersi. Per esempio, nella Quinta di Cajkovskij c’è un grande solo di corno (Muti me lo canta sommessamente): è chiaro che io conduco il cornista; ma, se si tratta di uno strumentista di grande valore, di una vera natura d’artista, ed esprime questa frase in modo interessante e convincente, io incasello la sua interpretazione in una inquadratura più grande che è la mia visione dell’opera».
Lei esegue spesso Cherubini, che però non è ancora entrato nell’orecchio del pubblico. Perché?
«Cherubini è un musicista per musicisti, è un musicista-architetto: non scrive temi per ammaliare il pubblico e diventare popolare. Ma è di tale capacità creativa e di tale nobile severità che ha avuto i consensi dei maggiori musicisti. Infatti Beetehoven, un altro architetto della musica, ammirava Cherubini. Schumann (tutt’altro che tenero verso i musicisti italiani) diceva che la marcia finale della Messa per l’Incoronazione di Carlo X è musica sublime. Grande ammirazione per Cherubini l’ha avuta anche Brahms che nella sua biblioteca aveva tante opere di Cherubini, ma di Verdi solo il Quartetto e neanche un’opera».
Lei si dedica alla riscoperta dell’Opera buffa. Qual è il valore di compositori come Galuppi, Porpora, Piccinni, soprattutto se pensiamo ai loro contemporanei, o quasi, Mozart e Haydn?
«Napoli era la capitale della musica. Il ‘700 napoletano (ma anche veneto, romano, bolognese) è stato la culla di tutto il mondo operistico successivo, non solo per i compositori ma anche per i cantanti. Senza Pergolesi e Cimarosa, senza cantanti come Farinelli e Cortona che hanno portato la musica teatrale in tutta Europa, ammirati e riveriti, il teatro musicale nell”800 sarebbe stato altro. Nella biblioteca di Napoli dormono migliaia di manoscritti pieni di grande musica: l’abbiamo visto nel Calandrino di Cimarosa e nel Matrimonio inaspettato di Paisiello, opere di altissima fattura ove si avvertono chiaramente elementi in seguito presi e sviluppati da Mozart che, senza la Scuola napoletana, dove affonda tante radici, sarebbe stato un genio diverso. Ma anche Haydn e Schubert pagano molti tributi alla musica italiana».
30 anni fa lei lasciò l’incarico di direttore principale al Maggio. Si parlava di giochi politici. Secondo lei, negli ultimi anni, da questo punto di vista, è cambiato qualcosa nella vita musicale fiorentina e italiana?
«A Firenze non lo so. Ma in Italia a lungo e forse tutt’ora la vita teatrale, musicale e non, è stata influenzata dalla politica. Questo è un errore perché naturalmente la musica dovrebbe essere, come ogni forma d’arte, libera da influenze o capricci ideologici. La mia carriera si è svolta soprattutto all’estero anche se sono stato molto a Firenze e alla Scala. E quando a Firenze negli anni ’70 facemmo Cavalleria rusticana e Pagliacci, ci fu addirittura una scandalizzata interpellanza in Comune su queste opere spazzatura. Sono state forme di fondamentalismo ideologico dannoso per l’Italia. Ci sono ancora rigurgiti di questo tipo ma credo che la società sia progredita e chi facesse tali discorsi, cadrebbe nel ridicolo».
È recente la notizia di tagli economici al Maggio. La già difficile vita di teatri e orchestre può peggiorare.
«Questo è un antico problema: io da 40 anni sono vox clamantis in deserto, anche se non voglio paragonarmi a Giovanni Battista che finì decapitato. Ma sembra che la cultura sia una specie di istituto di assistenza cui ogni tanto dare quattro soldi. Il problema è complesso: bisogna capire che l’Italia ha una delle sue arterie portanti nella cultura e nella musica in particolare. Come detto, l’Italia è il paese dei teatri chiusi; le forze locali dovrebbero aprirli ai giovani che praticano prosa, musica, balletto e far sì che i talenti che hanno idee, le possano applicare, nutrire. E dai rivoli provenienti da questi teatri, potrebbe nascere nuova linfa per ravvivare una situazione culturale un po’ stagnante. Tagliare i fondi alla cultura è grave: avviandoci verso la globalizzazione, perdere identità e radici, potrebbe farci cadere in un arido deserto. Sono importanti scuole, ospedali, strade, case ma non si può porre in secondo piano la cura dello spirito di un popolo».
Qual è il valore delle nostre orchestre paragonate alle maggiori compagini internazionali?
«I nostri complessi, anche i migliori, non sono competitivi con le maggiori orchestre internazionali. Non perché manchino bravi strumentisti: ce ne sono di strepitosi. Ma il nostro è un paese poco interessato alla cultura, un musicista vive precariamente, e per pressioni sindacali ci si preoccupa più del posto di lavoro (che è un fatto sacrosanto) che della qualità. Per cui in un’orchestra accanto a elementi di prim’ordine suonano elementi scadenti. Questo fa sì che non si arrivi al livello dei grandi complessi internazionali dove la percentuale di musicisti di eccellenza è molto elevata. C’è un altro motivo: negli anni ’50 e ’60 le nostre orchestre sono state messe al servizio di opere eseguite più che altro per soddisfare i capricci di questo o di quel cantante facendo sentire gli orchestrali dei poveri accompagnatori, causandone la caduta qualitativa. Da alcuni anni c’è un miglioramento e sono ottimista. Ma per ora Chicago, Vienna, Berlino, Filadelfia sono su un altro pianeta.