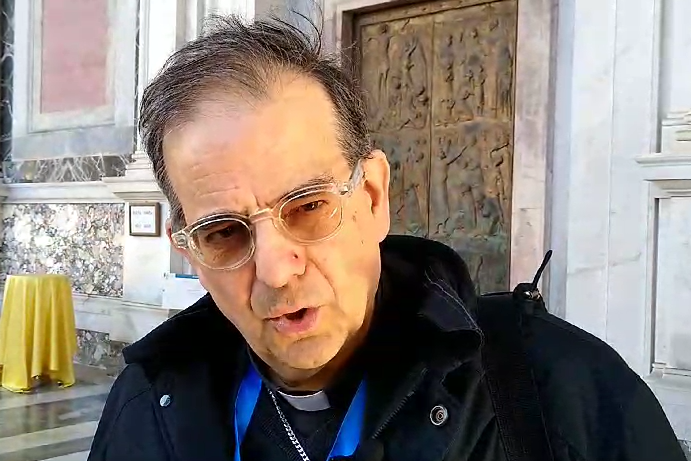Cultura & Società
Mito: lo abbiamo distrutto ma anche nel Duemila ne abbiamo bisogno
di Franco Cardini
Quando Max Pezzali faceva parte del gruppo degli OttoOttoTre, gli capitò di scrivere una canzone che fece successo e restò parecchio tempo in Hit Parade. S’intitolava Sei un mito: ed era fondamentale capolavoro antropologico, in quanto spiegava esattamente quel che il mito non è.
Secondo Pezzali, e ormai un po’ secondo tutti, il mito è qualcosa che coinvolge, che scatena, che fa perdere la testa, che è al tempo stesso inimitabile e irraggiungibile. Insomma, il prototipo della «democrazia paradossale» che sta alla base della società dell’immagine e del consumo: tutti debbono essere i migliori. Ovviamente, possono esserci anche i «miti privati»: un sogno da raggiungere, un amore, un film e così via.
D’altronde, si abusa della parola mito: non solo, ma si confonde abitualmente il concetto di mito con quelli di leggenda e di favola o fiaba, e naturalmente si sbaglia di conseguenza il rapporto di ciascuna di queste dimensioni con quella di quel che dovrebb’essere il racconto di quanto è avvenuto nella realtà, cioè con la storia.
Allora, vediamo di chiarire brevemente. La parola «mito» è l’italianizzazione del termine greco mythos, che proviene da una radice che indica sì il raccontare, ma un raccontare che ha come scopo il tramandare un segreto: non è un caso che tale radice sia la stessa dalla quale proviene l’italiano «muto», che indica colui che non parla. Al contrario, i due termini affini favola/fiaba provengono dal latino for che indica il verbo «narrare», «raccontare per esteso». La parola «leggenda», poi, è l’italianizzazione del gerundio femminile del verbo latino lego, «leggere»: una legenda è pertanto «qualcosa ch’è degno di esser letto», evidentemente o perché contiene una verità storica o perché trasmette un precetto etico.
La favola/fiaba è tutt’altra cosa: è un racconto fantastico, che può avere o no come soggetto creature o cose reali, ma il cui regno è quello della libera fantasia qualificata dall’incertezza del tempo e della realtà: «C’era una volta », diciamo noi; kan ma kan, «c’era e non c’era», dicono gli arabi. Ma, dal momento che alla fine del racconto ci si aspetta sempre un segno che ne riveli il carattere significativo, alla favola si applica solitamente una «morale», ch’è una sorta di piccolo kerygma a carattere etico.
La leggenda corrisponde a un’ulteriore dimensione. La parola nasce fondamentalmente dagli usi liturgico-pastorali cristiani: si riteneva utile e decoroso, nel corso di cerimonie o di riunioni, il leggere il racconto della passione di un martire, della vita di un santo, dello svolgersi di un miracolo, della fondazione di un santuario e via discorrendo. Alla leggenda si attribuiva correntemente un valore storico: si riteneva cioè che quanto veniva narrato dal martirologo o dall’agiografo corrispondesse a eventi storici realmente accaduti. Naturalmente, molte fiabe degli antichi, tramandate fino ai nostri giorni, sono state reinterpretate come «leggende» nel momento stesso nel quale si è perduto fiducia nella realtà storica delle leggende cristiane. Così, il racconto di Atteone che per aver assistito involontariamente al bagno della de Artemide viene da questa trasformato in cervo e sbranato dai suoi cani da caccia non è di per sé un myhos che richiami a un kerygma di valore cosmico (a differenza ad esempio del dio Chronos che divora i figli e che viene assurto a simbolo del tempo che consuma le cose che da esso stesso sono scaturite), ma può servire a spiegare in modo arbitrario in origine, ma destinato a divenir tradizionale, la forma di una pietra, la localizzazione di una sorgente e così via. Così ad esempio, in molte nostre strade medievali, i «ponti del diavolo», così chiamati in memoria di un qualche fatto terribile occorso nei loro paraggi o semplicemente per la loro ardua costruzione, che si riteneva impossibile come frutto dell’abilità umana.
I «miti di fondazione» delle città, ad esempio, non sono propriamente «miti» nel senso antropologico, bensì piuttosto «leggende», o più precisamente ancora «leggende storiche» in quanto racconti che raccolgono il più possibile di elementi storici ordinandoli nel tessuto della loro narrazione al fine di renderli il più possibile realistici, credibili e quindi utilizzabili al fine di quel che oggi si potrebbe definire «l’invenzione dell’Identità»: poiché, al pari della Tradizione, l’Identità è qualcosa di vivo e di dinamico che si costruisce e si modifica nel tempo. Se nel mito di fondazione di Roma è insito il mònito dell’intangibilità dei confini urbani nati dalla necessità di un popolo contadino di controllare il territorio (l’aratro e la spada) e dal bisogno di preservarlo dalle incursioni di pastori nomadi abituati invece agli spazi aperti, il mito di fondazione di Firenze può invece alludere al rapporto della città con la civiltà etrusca di Fiesole o con Roma, mentre quelli di Napoli o di Varsavia possono invece alludere al rapporto di tali centri con le acque marine o fluviali e via dicendo.
Ricorrere al mito, «fondare» un mito, «rifugiarsi» in un mito magari quello del passato, della laudatio temporis acti, del «si stava meglio quando si stava peggio» e così via può essere un segno di forte disagio sociale o esistenziale; ma può anche essere invece una grande astuzia massmediale e consumistica.
Cominciamo proprio qui, dal «mito come fuga». Non sono soddisfatto di me, e allora m’identifico in Bob Dylan o in George Clooney. Bene. Ma il punto è: il mio mito è l’illusione d’identificarmi con qualcuno o con qualcosa d’inarrivabile o la semplice volontà di fuggire da una realtà personale che avverto come penosa o come miserabile?
Difatti, si può fuggire verso qualcosa; oppure da qualcosa. Ed è ben diverso. Nel primo caso la fuga è ordinata, segue un piano, ha uno scopo positivo e propositivo. Nel secondo è convulsa, disordinata, disperata.
Ancora, c’è fuga e fuga. Più o meno mezzo secolo fa, quando si tentava di far accettare a tutti senza riserve il principio che solo l’impegno politico (e in una sola, ben determinata direzione) fosse cosa legittima, Elémire Zolla presentando il libro Il Signore degli Anelli di John R.R. Tolkien che in America era stato un successo ma che qui fece scandalo e che fu bollato come un libro «nazista», distingueva con energia tra la «diserzione del soldato» condannabile anche quando è comprensibile e la «santa fuga del prigioniero», che è un diritto riconosciuto dalle leggi di guerra e un dovere morale. Davanti a una realtà oppressiva e umiliante come quella d’una cultura egemonizzata da un materialismo sordo a qualunque istanza diversa da se stesso, argomentava Zolla, rifugiarsi nella fantasia eroica come facevano i ragazzi che stavano divenendo fans di Tolkien non solo è legittimo sotto il profilo morale, ma può costituire anzitutto un’ottima terapia spirituale e quindi un’eccellente fonte di rinnovamento culturale I fatti hanno provato che aveva ragione.
Ma il problema rimane. L’Occidente resta schizofrenico, teso com’è da un lato ad affermare la propria Volontà di Potenza come Migliore dei Mondi Possibili, dall’altro a giustificare una crisi ch’è ormai più che incipiente e che sta procurando paura e infelicità mentre diventa sempre più difficile darne la colpa ad altri (prima la si è data al nazismo, che è stato sconfitto: quindi al comunismo, che si è dissolto; ora al terrorismo islamico, su cui però incombono polte perplessità; e domani?… Quando ci decideremo a chiederci se per caso quel che non va non stia nelle nostre stesse scelte, nel meccanismo produzione-consumo-profitto che domina ormai la nostra cultura?).
Com’è noto, tentazione costante dello schizofrenico è il suicidio. L’evasione «fantastica», la «fuga nel mito», costituisce una valida e plausibile alternativa all’autodistruzione? Non è detto. Esistono evasioni che, lungi dall’esorcizzare il suicidio, lo affrettano. Non tutte le fughe anche quando sono sante riescono, perché non tutte sono fortunate e ben congegnate.
La schizofrenia dell’Occidente nasce dalla sua duplice, conflittuale radice etica. Da una parte chi crede come recita il capitolo 77 dell’enciclica Fides et Ratio che non tutto quel ch’è tecnicamente realizzabile sia anche moralmente accettabile; dall’altra chi ritiene, al contrario, che il progresso tecnico sia la misura-base per la stessa etica. L’Occidente è diviso tra chi guarda come alla propria guida al patriarca Abramo e agli esiti immediati e remoti del suo Patto con Dio e dalle regole che ne sono scaturite e che non hanno radice immanente e razionale, e chi guarda invece al dottor Faust.
Poteva essere una nuova dimensione, quella dell’utopia, del credere in «un luogo che non c’è» (ma che potrebbe esser costruito domani dalla volontà umana) un tipo di «fuga» terapeuticamente proponibile per chi avesse voluto uscire da quest’angoscia? Il fatto è che almeno un tipo di utopia, quella tesa alla giustizia sociale e alla creazione di un «uomo nuovo» libero dal bisogno e dall’egoismo, è naufragata con il dissolversi del socialismo reale.
Si può invece fuggire rifugiandosi nel mito o nella storia? Nell’intemporale in cui abitano i Grandi Modelli, gli Archetipi, o nel passato per definizione sentito come «migliore» del presente?
Quanto al primo tipo di fuga, diciamo ch’esso non è neppur tale. Il mito è come il sonno e il sogno, ai quali somiglia. La parola nasce dalla stessa radice del verbo greco myein, che significa «iniziare», ed è imparentata con la parola «mistero». Quando il povero Bertolt Brecht diceva «Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi», non solo perdeva un’ennesima occasione di star zitto, ma dimostrava di non aver capito né che cosa sia un popolo, né che cosa sia un eroe. Di eroi, cioè di modelli, si ha sempre bisogno. Senza modelli, non vi sarebbero né linguaggi, né comunità umane.
Il discorso sulla storia è diverso. Le «scienze pure» non esistono: ma, fra tutte, la storia è una delle più impure. Essa nasce e si sviluppa, da Erodoto in poi, al fine di esercitare e disciplinare la memoria, di uscire dal continuum informe che la caratterizza e dall’angoscia che esso genera. La storia è un combattimento contro l’oblìo (una «lotta illustre contro il tempo», la definiva lo Pseudanonimo manzoniano), ma il suo «ricordare» non è affatto un’operazione puramente e «naturalmente» mnemonica, un ordinare e catalogare materiali già pronti. Al contrario: «l’uomo diceva Lucien Febvre non ricorda nulla: ricostruisce sempre». E, ricostruendo, interpreta: lavoro esegetico delicatissimo, che esige scelte continue.
Quel che ne deriva è un equilibrio dinamico e difficilissimo tra l’istanza dell’onestà intellettuale e scientifica, che impone un’assoluta equità dinanzi alle fonti e a quel che emerge dallo studio sistematico del passato, e l’istanza esegetica che fornisce di continuo chiavi interpretative della realtà passata che influiscono sulla sua stessa sostanza. A ciò si aggiunga il progresso obiettivo nelle tecniche e nei metodi della ricerca: i quali fanno sì che una più fedele aderenza a quanto accaduto nel passato stia, per definizione, nelle future letture di esso che potremo fornire di esso alla luce di mezzi e di sistemi sempre più efficaci.
Prendiamo un oggetto abituale di «luogo» nel quale di solito si cerca di rintracciare quelle radici: il cosiddetto medioevo (un’espressione, ricordiamo, che indica un periodo molto ampio e comunque convenzionalmente identificato ai fini d’una periodizzazione storica che dev’essere intesa in modo sempre relativo), soggetto e al tempo stesso vittima di queste continue mistificazioni. Una delle responsabili di essa è senza dubbio la mancanza o la forte carenza almeno in Italia d’una divulgazione seria e qualificata, che funga da filo diretto tra ricerca scientifica e dinamica della formazione delle cognizioni diffuse. Quindi, da una parte carenza di studiosi seri che accettino come parte delle loro funzioni anche quella d’informare in modo corretto ma semplice un più vasto pubblico; da un’altra, di organismi massmediali in grado di discernere e coinvolgere nei momenti divulgativi le persone giuste, evitando ciarlatani e mestieranti; da un’altra ancora, d’una scuola che si preoccupi costantemente di quell’aspetto fondamentale della crescita culturale del paese ch’è l’aggiornamento degli insegnanti (che brilla per assenza nella recente riforma).
In quanto medievista, non mi fa per nulla piacere che la gente e in modo speciale i giovani «fugga» dal presente «rifugiandosi» nel medioevo. Mi preoccupa, anzi, e mi fa rabbia: perché quel medioevo ch’essi di solito cercano è falso, non è mai esistito. È un medioevo di cartapesta: figlio ora della «leggenda nera» che, sulla scia di alcuni illuministi, lo vuole età di violenza, d’oppressione, di fanatismo, di barbarie e d’ignoranza; e ora della «leggenda dorata» che, sulle orme di alcuni romantici, lo vuole tempo di fede e di generosità, di eroismo e di fantasia.
Si può fare, qualcosa del genere. Forse: cominciando a correggere alcune tendenze attuali. Ad esempio, il ridicolo paradosso italiano. Mentre il medioevo difatti raggiunge sulle nostre piazze, con gli spettacoli e le rievocazioni, un fatturato immenso, il governo taglia i fondi alla massima pubblica istituzione incaricata di coordinarne lo studio, l’Istituto storico italiano per il Medio Evo sito in Roma, che dovrà chiudere i battenti perché gli si è tagliato fondi d’entità meno consistente di quanto ci serva il mantenimento del contingente militare italiano in Afghanistan per un giorno solo. C’è una logica, in tutto questo? Non sarebbe necessaria una risposta seria e corale del popolo italiano? I tunisini l’hanno già data.