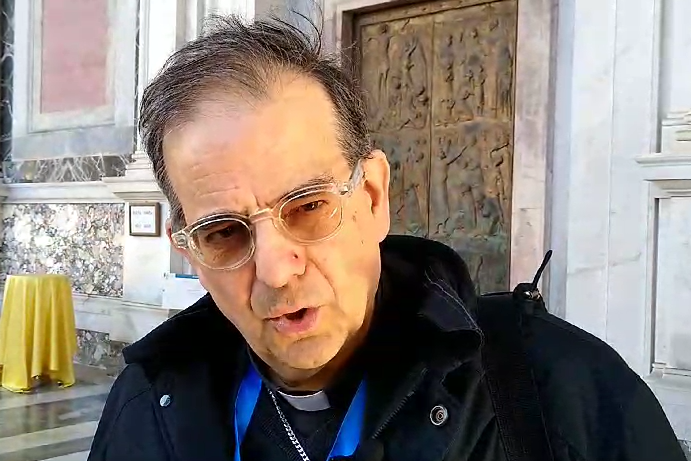Cultura & Società
Le leggende della Terra toscana

I testi sono opportunamente raccontati seguendo i racconti dei narratori locali, confrontati con le tradizioni scritte, arricchite delle loro comparse nei testi letterari, del valore storico, del significato nella memoria delle varie comunità. Ogni narrazione è quindi dotata di apparato critico, filologico e storico in modo da ricostruire nella sua interezza il valore di testo letterario popolare, documento antropologico, testimonianza storica.
Presa nei singoli documenti la materia si presenta quasi come insieme di suggestiva curiosità; assunta nel suo insieme ci si trova di fronte a un complesso meraviglioso, un mondo incantato e perduto, una creazione collettiva di una fantasia onnipotente e sterminata che ha pervaso, animato e dato vita ai luoghi di una parte della terra tra le più ricche e suggestive per moltissimi aspetti: luoghi naturali, personaggi storici, curiosità, fenomeni, piante, animali, opere d’arte, soggiorni di santi, vestigia etrusche, teatri di battaglie, tracce di tempi di cui si è smarrita ogni memoria.
Vista anche da questa prospettiva la Toscana si presenta come assolutamente singolare per la straordinaria ricchezza, varietà, profondità e antichità dei reperti, sì da apparire come una singolare, vasta mitologia di un passato antichissimo e glorioso, ma soprattutto carico di umanità da prendersi nelle virtù come nei vizi sempre straordinaria e mai ripetitiva e meschina.
Immette nella percezione di un’altra dimensione della vita che ebbero gli antichi un vasto saggio introduttivo che abbraccia la leggenda in generale e specificamente analizza quella toscana con i suoi temi particolari, le caratteristiche che ricalcano quelle dei suoi popoli.
L’introduzione si connette strettamente all’annotazione dei testi esplicati, studiati, interpretati e rivela di quale ricchezza sterminata di risorse fantastiche sia costituito il patrimonio di questa regione che presenta tutti gli aspetti del leggendario: da quello delle Alpi Apuane, a quello del mare lungo la costa tirrenica e dell’Arcipelago toscano, a quello dei monti dell’Appennino, dei laghi, dei fiumi, delle campagne e delle foreste, perfino di zone vulcaniche come l’Amiata. In più le storie segrete di geni dell’arte, della scienza, della politica, degli eroi popolari, oscuri quanto splendidi nei loro gesti divenuti leggendari, sono studiate in un ampio saggio introduttivo. Si scopre così una vera un mondo dimenticato di vicende, di temi, di motivi che vanno dalla vendetta shakespeariana alla beffa boccaccesca, sempre carichi di allusione, di significato, e di un messaggio riposto che è la sostanza della leggenda.
Antiche città scomparse, mitici re e mitici eroi dell’Etruria arcaica, grandi tombe di grandi sconosciuti o grandi dimenticati, luoghi misteriosi di riti celebrati periodicamente da animali, orme di santi nelle acque, sulla terra, in cielo, fantasmi che si aggirano nelle ombre, in fondo ai laghi, esseri trasformati da potenze magiche, divine, tracce indelebili di diavoli, stravaganze di artisti lasciate nei loro capolavori e molto altro ancora sta dentro queste pagine.
Carlo Lapucci, Le leggende della terra toscana, Sarnus, Firenze 2011, pp. 656, euro 24,00.
C’è da immaginare quanto quel negromante chiedesse aiuto al suo amico e compare, il quale gl’insegnò uno stratagemma per sparire agli occhi di tutti proprio sul patibolo.
C’era però a Firenze un prete, conoscitore di segreti magici e di cose diaboliche, il quale capì come avrebbe fatto Cecco a dileguarsi e scampare al rogo: se vicino alla sua pira avesse bevuto un sorso d’acqua, nessuno l’avrebbe più visto e avrebbe potuto tranquillamente allontanarsi dalla piazza e fuggire.
Stavano già portando il condannato al supplizio e il prete, non potendo avvicinarsi, salì sul campanile di Santa Maria Maggiore e, quando Cecco passò sotto in via de’ Cerretani, si sporse gridando:
Non dategli da bere, altrimenti non morirà.
Cecco si vide scoperto e si sentì perduto, ma volle vendicarsi facendo ricorso alle sue arti e rispose:
E tu il capo non caverai di là!
Il prete rimase folgorato e impietrito. È ancora là: basta alzare gli occhi da Via de’ Cerretani al campanile di Santa Maria Maggiore per vederlo nel muro del campanile, dove lo inchiodò Cecco d’Ascoli con la sua maledizione.
Questa Ghita era una donna belloccia e vispa e il pozzo si trovava davanti alla porta della sua casa. Era sposata a un certo Tofano, un uomo ricco e molto geloso che le rendeva la vita un inferno. Per di più aveva anche il vizio di bere, per cui avere un simile marito era per la Ghita più una disgrazia che una consolazione.
Essendo giovane e avvenente, non le mancarono le occasioni per farsi un amante che andava a trovare la notte quando Tofano, ubriaco, s’addormentava e russava come un tasso.
Una notte però Tofano, forse per aver bevuto meno del solito, si svegliò ben in sé, cercata la moglie nella casa e non trovandola, geloso com’era, andò su tutte le furie. Scese a chiudere il portone a chiavistello e si mise ad aspettare alla finestra.
La donna ritornò poco dopo e, trovata la porta chiusa, alzò gli occhi alle finestre. Vedendo il marito affacciato, gli disse di scendere ad aprire.
Tu, svergonata, resti fuori: te ne ritorni dove sei stata e ci rimani, perché ora chiamo gente e ti sputtano per tutta Arezzo!
La Ghita lo pregò e lo ripregò. Poi disse:
Guarda che se non mi apri mi butto nel pozzo.
Tofano non si mosse. Allora, siccome era buio pesto, la Ghita scivolò fino al pozzo, riempì la secchia di pietre e la lasciò cadere.
A sentire quel tonfo Tofano, spaventato, scese coi capelli ritti e uscì. In quel mentre la moglie entrò in casa e tirò a sua volta il paletto. Poi, salita alla finestra, cominciò a urlare e a chiamar gente:
Venite, che questo briaco m’ammazza… Tutte le notti torna in queste condizioni e grida, bestemmia e picchia… Non ne posso più di questa vita! Aiutatemi che questo diavolo un giorno o l’altro m’ammazza.
Accorsero i vicini, parenti, altra gente e ne nacque una tale confusione che Tofano dovette prendersi i rimproveri e, alla fine, rassegnarsi.
Quando San Luca tornò e lo vide in quelle condizioni non poté fare a meno di ridere; poi, guardandolo bene, disse:
Bravo, ora sei proprio bello. Rimarrai così e sarai il gruccione.
I Demoni avevano scavato un cunicolo dall’inferno per andare a prendere le anime dannate finché una notte non vi sprofondò la carrozza di Lucida Mansi, portata all’inferno dal Diavolo.
Da allora in quel luogo è venuto un lago, le cui acque nascondono la via d’accesso all’inferno. Infatti dall’acqua salgono nella notte lamenti di gente disperata, bagliori di fiamme, singhiozzi, invocazioni.
Nelle notti di luna Lucida, che non può dimenticare la bella vita fatta a Lucca, risale l’antro e s’affaccia a guardare: allora, grande nel lago, appare la sua faccia ancora bellissima e, quanti per ventura l’hanno vista non riescono più a dimenticare.
Aronte tuttavia, che sapeva del passato, del presente e del futuro, vide che il loro amore sarebbe stato infelice perché, mentre sarebbe lui invecchiato con gli anni, la Sirena sarebbe rimasta eternamente giovane.
Per questo chiese alla sua amata se l’avrebbe lasciato quando sarebbe diventato vecchio. La Sirena rispose che non l’avrebbe mai abbandonato e Aronte, anche se vedeva nel fondo degli anni che non sarebbe stato così, non seppe resistere all’amore.
Passò molto tempo nel quale i due vissero felici, ma poi s’avverò quello che l’indovino aveva previsto: l’uomo si fece vecchio, debole, taciturno e la Sirena rimase giovane e bella come era sempre stata.
Anche se i propositi erano stati buoni, la figlia del mare cominciò ad essere stanca di quel vecchio e di quei luoghi. Quando nelle acque del Carrione apparve un delfino, risentì improvvisamente la nostalgia del mare e, senza pensarci sopra, lasciato Aronte, saltò in groppa al delfino e cominciò a ridiscendere il fiume. Quando furono nei pressi del Ponte delle Lacrime, li vide Giove dall’alto del Monte Sagro e s’adirò per il tradimento della bella Sirena. Tuttavia non volle incenerirla col fulmine e, mentre andava sul pesce che nuotava, la condannò a lacrimare per sempre e la tramutò con la sua cavalcatura in una fonte marmo.
I due sono ancora là, lungo la via Carriona, presso il ponte che fu detto delle lacrime.
I pisani poi invitano i visitatori a contarli e quasi sempre chi ci prova perde il conto. Dicono infatti che, anche facendo la cosa con tutto l’impegno, il numero risulta sempre diverso se si comincia dall’alto o dal basso.
È questo il segno lasciato dal Diavolo perché ci si ricordi del suo passaggio. Infatti il Maligno pensò una notte d’andare a rubare in Duomo. Aveva fatto già un bel bottino, quando S. Ranieri si svegliò nella sua urna per il baccano che faceva il ladro. Il Santo, preso un pesante candelabro, riempì il Maligno di botte costringendolo a lasciare tutto quello che aveva preso.
Il Diavolo scappò e San Ranieri dietro col candelabro. Il Demonio cercò scampo sul tetto della cattedrale, arrampicandosi con gli unghioni per la parete e lasciandoci le vistose impronte. Anche San Ranieri s’arrampicò per il muro, lasciando segni meno profondi, poi, visto che il maledetto aveva spiccato il volo dalla cupola, tornò a dormire tranquillo nella sua urna.
La ragione di una posizione così felice e di tanta bellezza consiste nel fatto che Baggio fu l’ultimo luogo del mondo ad essere creato da Dio.
Dopo aver fatto tutta la terra il Signore s’era fatto la mano e faceva cose sempre più belle. Venne anche il giorno che era tutto finito e, preparandosi a tornare in cielo, s’accorse d’avere in mano l’ultimo pugno di fango che gli era avanzato.
Con questa terra quasi quasi ci faccio Baggio!
Batté il fango sul monte, gli dette quattro buone e sapienti ditate e fu per sempre Baggio, l’ultimo paese del mondo ad esser creato.
Era sbarcato con la mercanzia all’Isola Canaria e aveva intrapreso il suo commercio quando, attraverso un cortigiano ebbe modo di presentarsi al cospetto del re e da questi venne invitato a un banchetto.
Come comparvero in tavola le prime portate, subito sbucarono da ogni parte frotte di topi che cominciarono a contendere i bocconi ai commensali e questi dovevano scacciarli continuamente, se volevano mangiare. Arrivarono anche molti servi che con mazze e palette, cercavano di tener lontani i topi o li uccidevano.
Franco Datini non ci stette a pensare tanto e, chiesto il permesso, andò alla sua nave e tornò portando al re una bella gatta, che lasciata libera cominciò subito a far strage dei topi, tanto che in poco tempo i ratti fastidiosi cominciarono a tenersi a rispettosa distanza.
Datini fece dono al sovrano del provvidenziale animale e il re a sua volta donò al mercante una quantità favolosa di gioielli.
Conclusi i suoi affari Datini ripartì, ma non era passato un anno che fece ritorno alla Canaria con un bel gatto maschio che donò al sovrano, ottenendone un compenso doppio di quello dell’anno prima.
Così cominciò la fortuna di Franco di Marco Datini.
Il guerriero, che era molto orgoglioso, pensò che il suo valore l’avrebbe portato, come a Montaperti, ad essere il primo nella lotta e a sbaragliare il nemico, aumentando la sua gloria.
Ma le cose andarono diversamente: venuti alle armi, presso Colle Valdelsa, le schiere senesi dei ghibellini furono disfatte da quelle guelfe fiorentine e Provenzano, caduto nel campo di battaglia, fu decapitato: la sua testa fu posta sopra una picca e fu portata per tutto il campo in modo che ognuno la vedesse.
Così s’avverò la predizione della strega che Provenzan Salvani non aveva voluto intendere.