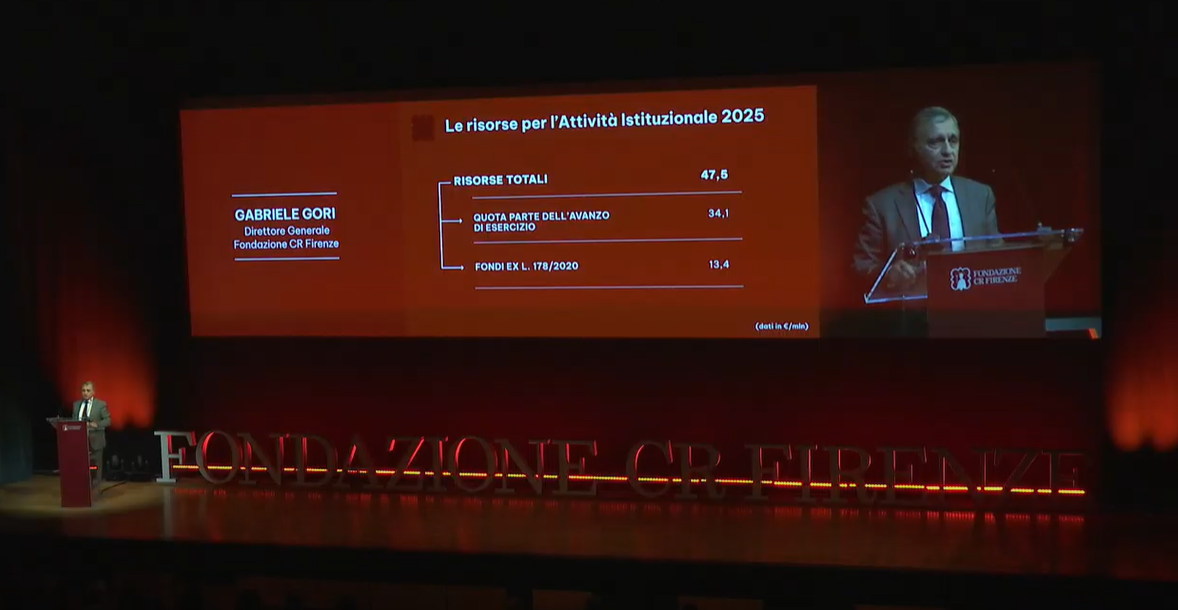Toscana
Betlemme, i toscani forzano l’assedio

Anzi, adesso i blindati con la stella di David si sono piazzati anche nella strada che divide la scuola dei francescani dal convento, proprio sotto le finestre della stanza di padre Ibrahim Faltas, il quale, disperato, rimane in costante contatto telefonico con la delegazione «costretta» a Gerusalemme.
Il «soggiorno forzato» offre comunque di visitare i luoghi santi nella più completa solitudine. Ma quella che per l’improvvisato pellegrino è un’opportunità, per la gente del posto, a partire dai cristiani, è una tragedia. «Non viene più nessuno ci dice padre Emilio, responsabile della Casa Nova di Gerusalemme, l’ostello dei francescani : il lunedì di Pasqua avevamo tre persone, il giorno dopo una. Restiamo aperti per dare un segnale di speranza alle persone che vivono qui intorno».
Lo stop di Gerusalemme permette anche una visita notturna al Muro del Pianto, dove la preghiera degli ebrei si fa incessante, e capita di vedere, come non mai, un gran numero di donne nella parte a loro riservata. E poi, la mattina successiva, la solenne Messa cantata dai francescani al Sepolcro, la rapida visita alla piccola Comunità di Bose, nella zona della chiesa siriana di San Marco, a ridosso del quartiere armeno. «Siamo solo tre monaci, ma per noi ci spiega padre Alberto quello che conta è la presenza qui, nella Città Santa».
E se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto. Ecco allora che nella tarda mattinata di martedì si diffonde la voce che padre Ibrahim sta arrivando: proprio lui, l’amico della Toscana, uno degli artefici della conclusione pacifica dell’assedio alla Basilica della Natività, il protagonista indiscusso di fronte ai mass media e al mondo. E da par suo, dopo una lunga trattativa, non poteva che uscire da Betlemme scortato da un carro armato davanti e uno dietro.
L’arrivo di padre Ibrahim dà il via libera anche all’incontro con Arafat. Ma l’ingresso a Ramallah è più difficile del previsto. Al check point principale i giovanissimi soldati israeliani ci fanno scendere dal pullman. Inizia un’estenuante trattativa, mentre una folla di palestinesi è assiepata a ridosso del filo spinato in attesa di sapere se potrà rientrare a casa. C’è anche un uomo con in braccio una piccola di pochi mesi. A gesti fa capire che la mamma è dall’altra parte, da dove, però, non si esce.
La via del ritorno si annuncia difficile. Si opta per una mulattiera in direzione nord per evitare il check point. Ma le cose non vanno meglio. Al posto di blocco «alternativo» i soldati sembrano più sprezzanti e a stento tengono a bada un folto gruppo di palestinesi che aspetta inutilmente di uscire. Ci intimano di metterci in coda insieme agli altri fino a che, grazie ai tentativi di padre Ibrahim e del ministro palestinese che ci accompagna, riusciamo a passare. Appena il tempo di scollinare e sentiamo due spari in rapida sequenza: «Sono solo candelotti lacrimogeni», dice qualcuno per tranquillizzarci.
Ma l’avventura non è finita. Per tornare a Gerusalemme siamo costretti a salire su alcuni taxi multipli, che per evitare i controlli sulle strade principali attraversano tratti sterrati, sconnessi e tra le rocce. Quando finalmente arriviamo alle porte di Gerusalemme, giunge la notizia di un agguato contro due coloni ebrei nella zona di Hafra, da dove siamo appena passati. Scattano nuovi controlli. È allarme rosso anche per un possibile attentato a Gerusalemme, ma poi, all’ultimo tuffo e con grande emozione, entriamo anche a Betlemme, ancora sotto l’assedio dei carri armati israeliani.