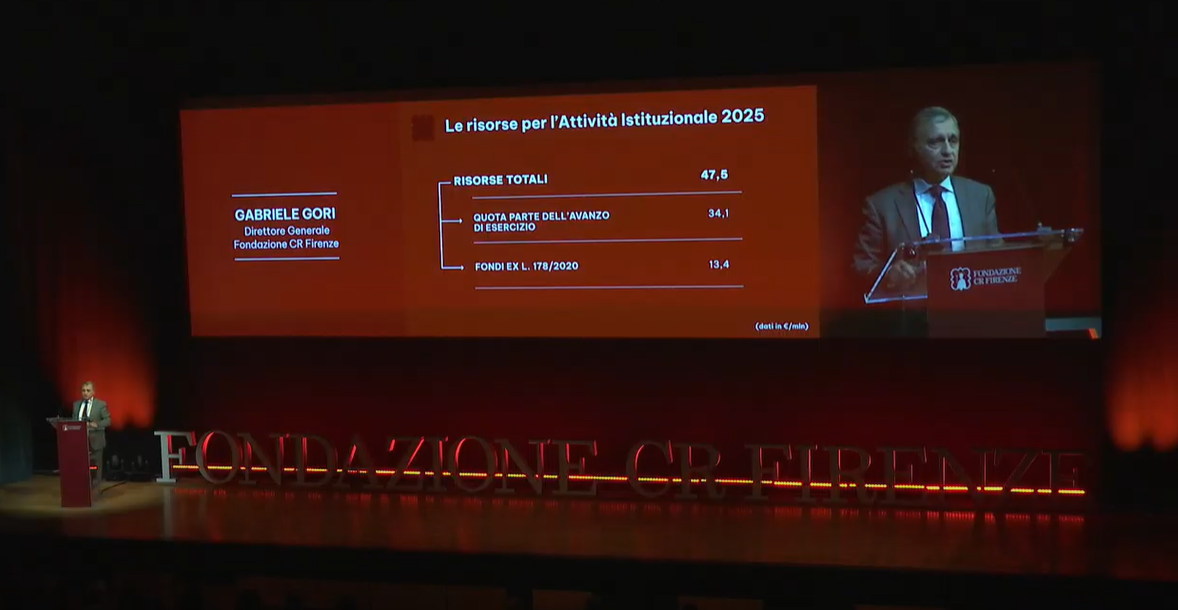Toscana
Referendum, guida al voto

Domenica 12 (dalle 8 alle 22) e lunedì 13 giugno (dalle 7 alle 15) gli italiani sono chiamati di nuovo alle urne per i referendum. Quattro i quesiti ammessi al voto, due riguardano la gestione dei servizi pubblici e dell’acqua in particolare, uno è sulla legge del «legittimo impedimento» e il quarto è sulla costruzione di centrali nucleari. Per quest’ultimo il Parlamento era intervenuto approvando un articolo del decreto omnibus, che cancella le norme sottoposte al quesito, ma che non chiude la strada al ritorno al nucleare in Italia. E la Cassazione ha deciso che si voterà anche per questo. Ecco una guida al voto. Il testo dei quesiti
Due referendum affrontano da angolature diverse lo stesso problema: il primo riguarda infatti tutti i servizi pubblici locali a rilievo economico (e non solo all’acqua), il secondo invece tocca proprio le tariffe dell’acqua. Il primo chiede l’abrogazione di tutto l’articolo 23-bis della legge 133/08, sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilievo economico da parte delle amministrazioni pubbliche. L’articolo non riguarda farmacie comunali, gas, energia elettrica e trasporto ferroviario regionale, che sono disciplinati da norme speciali.
Oggi un ente locale eroga molti servizi pubblici: l’illuminazione votiva nei cimiteri, il trasporto scolastico, il servizio idrico, l’assistenza sociale, le case di riposo. Queste attività sono considerate servizi pubblici, cioè sono gestiti per erogare una prestazione ai cittadini. La concreta prestazione del servizio pubblico secondo l’articolo 23-bis deve (e non può) avvenire in uno dei seguenti modi:
1. privato imprenditore o una società;
2. una società di capitali mista pubblico-privata;
3. L’ente locale lo trattiene per sé e lo può gestire mediante una società di capitali, interamente pubblica, di cui la proprietà è dell’ente stesso o di più enti.
Questo assetto deriva dalle direttive europee, che sul punto, però, sono state recepite dal nostro Paese in maniera più restrittiva, come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale. L’Ue, nel «Libro Verde sui servizi pubblici» del 2004, non chiede infatti di affidare i servizi necessariamente ai privati, ma lascia liberi gli Stati di scegliere una strada che tuteli la concorrenza e il mercato.
L’articolo 23-bis della L. 133/08 è stato poi modificato, nel 2009, dal decreto «Ronchi» (L. 166/09), che ha definitivamente stabilito che i servizi pubblici locali a rilevanza economica, nessun escluso (quindi non solo l’acqua), debbano essere affidati ai privati e, solo eccezionalmente e dopo una lunga istruttoria, possano essere gestiti in proprio, mediante società pubblica, su parere, obbligatorio, dell’Autorità per la concorrenza e il mercato. In sostanza il decreto Ronchi pretende che la decisione degli enti locali debba (e non possa) essere, per legge, orientata prima al privato e, poi, al pubblico. Infatti obbliga gli enti a scegliere, ovviamente con gara pubblica, un soggetto privato, cioè una società di capitali (srl o spa) per erogare il servizio per i cittadini; oppure l’ente potrà costituire, comunque, una società mista pubblica privata, ma in cui il privato abbia almeno il 40% del capitale (quote o azioni) della società, appositamente costituita. Così dal 2009 il nostro Paese ha scelto per tutti i servizi pubblici locali di rilievo economico la strada della «necessaria» privatizzazione, o almeno si può dire, ha reso molto difficile la gestione in proprio dei servizi.
Se al referendum prevalessero i «sì» l’articolo 23-bis sarebbe abrogato e si applicherebbe l’articolo 113 del testo unico degli enti locali, il decreto legislativo n. 267/00, che è più permissivo rispetto alla possibilità di costituire una società interamente pubblica per gestire qualsivoglia servizio pubblico. Sul punto tra i costituzionalisti si discute, però.
Il secondo quesito, invece, è specificamente dettato per abrogare una norma del testo unico dell’ambiente, il decreto legislativo 152/06, che riguarda la tariffa del servizio idrico integrato (cioè la gestione dell’acqua). Si chiede di abrogare l’articolo 154, comma 1, solo ove parla del compenso per il capitale investito. Tale norma riguarda la tariffa dell’acqua che, nel testo della legge, è specificamente chiamata corrispettivo. L’intento del comitato promotore qui è molto chiaro. Se si abroga una norma che prevede che la tariffa dell’acqua sia «un corrispettivo», che serve anche a ricompensare il privato gestore per l’uso del proprio capitale, che giuridicamente equivale ad un prezzo, allora il bene acqua non avrà esattamente un valore di mercato, liberamente oscillante secondo le esigenze del privato gestore (vedi primo quesito), ma il legislatore sarà costretto a vederlo come una tassa, cioè disciplinata con legge e a porlo a carico della fiscalità generale, magari. In sostanza avremo un prezzo pubblico in cui «la ricompensa al privato per il capitale che investe» non c’è più.
Se prevalessero i «sì» al secondo quesito la nolegge e resterebbe un vuoto legislativo che il Parlamento dovrebbe colmare urgentemente e coerentemente con il risultato del referendum, approvando nuove norme, se non proprio conformi, almeno non palesemente in contrasto con la volontà popolare.
Il Governo con il decreto legge sullo sviluppo, il n. 70/11, all’art. 10 ha previsto la istituzione dell’Agenzia di vigilanza delle risorse idriche che assorbe le competenze di cui i referendum discutono. Esso, è infatti, autorità di progettazione e controllo del mercato dell’acqua. E questo, secondo alcuni toglierebbe molto significato ai due quesiti referendari, anche se non li evita.
E’ stato in occasione dell’VIII edizione di Terra Futura la kermesse fiorentina dedicata alla sostenibilità e promossa da Fondazione culturale responsabilità etica onlus, Regione Toscana, Adescoop-Agenzia dell’economia sociale, in partnership con Acli, Arci, Caritas italiana, Cisl, Fiera delle utopie concrete, Legambiente… , che le Caritas toscane hanno presentato la campagna: «Acqua: dono di Dio, bene comune e responsabilità sociale». Si tratta di una campagna di pastorale promossa congiuntamente da Caritas, Missio e Pastorale Sociale e del Lavoro della Toscana che riprende i grandi temi lanciati dalla campagna promossa a livello italiano dalla Rete interdiocesana sui nuovi stili di vita, alla quale aderiscono oltre 40 diocesi e diversi uffici pastorali in tutta Italia.
La campagna invita a una riflessione ampia sull’importanza dell’acqua intesa come dono della creazione, con un excursus sul significato simbolico e vitale che essa assume nelle Scritture. Facendo riferimento alla Dottrina sociale della Chiesa si sottolinea anche come l’accesso ad essa costituisca un diritto universale inalienabile per le persone e che, come tale, ad essa si applica il principio della destinazione universale dei beni, ponendo un problema di giustizia nel momento in cui viene messa in dubbio la reale fruizione di questa. È infatti da considerare che oltre un quarto della popolazione del pianeta ancora non ha accesso a una quantità minima di acqua pulita.
La proposta della campagna è quindi triplice: in primo luogo recuperare l’atteggiamento di gratitudine e condivisione dovuto a un dono di Dio, pensato per tutti gli uomini, in secondo luogo richiamare a stili di vita responsabili che tutelino il diritto all’accesso all’acqua come bene comune e che continuino ad esigere una gestione comunitaria delle risorse idriche, orientata alla partecipazione di tutti e non determinata alla logica del profitto.
In vista del prossimo referendum, infine, si ricorda l’importanza di partecipare attivamente al dibattito sulla gestione dell’acqua, salvaguardandola come bene comune e diritto universale ed evitando che diventi una merce privata o privatizzabile, ma ripubblicizzandola mediante una forma di gestione pubblica e partecipata dei servizi idrici.
Gli stessi contenuti proposti dalla campagna sono stati oggetto recentemente anche del saluto di mons. Crociata, segretario della Cei, all’apertura del Convegno di Assisi dello scorso 16 aprile. In quell’occasione ha detto: «L’acqua rimane una risorsa male distribuita e male sfruttata. Senza indulgere in facili catastrofismi, accanto a zone nelle quali la scarsità di acqua è un fattore endemico penso, in particolare, alla fascia dell’Africa Settentrionale oggi ci misuriamo con un incremento significativo del processo di desertificazione; con il calo di disponibilità idrica, anche a fronte della crescita della popolazione mondiale; con un aumento dei consumi nell’attività produttiva; con l’inquinamento che ne frena, quando non ne impedisce l’utilizzo; con problemi di raccolta e di distribuzione che degenerano in sprechi, espressione di una politica sociale che non considera il dovere e la necessità di economizzare questo bene essenziale. In questo scenario conservano tutto il loro peso i processi di privatizzazione, che vedono poche multinazionali trasformare l’acqua in affare, a detrimento dell’accesso alle fonti e quindi dell’approvvigionamento, con conseguente perdita di autonomia da parte degli enti governativi».
Questi stessi argomenti, sposati con forza dalle tre realtà pastorali toscane (Caritas, Missio, Pastorale Sociale e del lavoro), sono stati ribaditi a Terra Futura dove, grazie al contributo dei ragazzi in servizio civile e in anno di volontariato sociale presso Caritas, si è allestito un corner di «degustazione delle acque» di fonte e si è riflettuto sulle seti dell’umanità, a partire dal tema proposto da Caritas Italiana: «micro-azioni per macro-valori». I contributi della campagna possono essere scaricati dal sito di Caritas toscana www.caritastoscana.it.
I referendum del 12 e 13 giugno hanno avuto per lo meno il merito di mettere in evidenza un argomento di importanza cruciale per l’intera cittadinanza. Sul tema, la FederUtility (federazione che unisce le aziende di servizi pubblici locali, fra i quali quelli idrici) e Confservizi Cispel Toscana (associazione che opera a livello regionale con lo stesso genere di imprese), hanno promosso, venerdì 20 maggio , presso palazzo Capponi a Firenze, un convegno dal titolo «Acqua: bene pubblico, gestione industriale». Secondo il vice presidente FederUtility Mauro D’Ascenzi, tuttavia, «nella concitazione della discussione si rischia di non compiere una riflessione matura, rimanendo a un livello di principi troppo astratti. Anche se lo statuto giuridico dei gestori è importante, non bisogna dimenticare che è la fruizione dell’acqua, nella sua concretezza di elemento, a entrare in gioco».
Sintetizza la posizione Erasmo D’Angelis, presidente Publiacqua (società affidataria della gestione del servizio idrico dell’ATO – Ambito Territorio Ottimale – 3 Medio Valdarno, che copre il territorio della Toscana centrale): «Questo non è un referendum contro la privatizzazione dell’acqua, perché l’acqua è e rimarrà in ogni modo un bene pubblico, come attesta la Legge Galli del 1994 e ribadisce il decreto Ronchi, oggetto del referendum». Quello che in effetti è in questione è la gestione di questo bene, che però anche attualmente, secondo D’Angelis, è affidato alle scelte degli enti pubblici: «Sono i comuni, riuniti in Ato, proprietari di reti e infrastrutture, a decidere a quali soggetti pubblici, privati o misti demandarne la gestione. La scelta dipende dunque da sindaci eletti democraticamente». D’Angelis si dichiara molto favorevole alla Legge Galli, «che ha finalmente posto fine a una situazione insostenibile di frammentazione degli operatori idrici, che erano 13 mila nel 1994: introducendo gli Ato tutta l’organizzazione è stata resa molto più moderna ed efficace». Ma difende appassionatamente anche il Decreto Ronchi del 2009, che ha reso obbligatoria una gara pubblica per l’assegnazione di questi servizi: «La rete idrica italiana ha bisogno di investimenti per almeno 64 miliardi di euro nei prossimi 30 anni, per far fronte ai quali non possiamo certo affidarci allo Stato e al suo colossale debito pubblico, né agli enti locali e alle loro risicate risorse». Per questo motivo i sostenitori del «no» al referendum ritengono necessaria una gestione idrica di tipo «industriale», «come nel resto dell’Europa. Altrimenti la qualità dei servizi e quello della stessa acqua erogata rimarrà sempre insufficiente, con il rischio di incappare in sanzioni a livello comunitario».
L’altro quesito referendario riguarda l’abrogazione della «remunerazione del capitale investito», ossia che i soggetti che investono in questo campo non possano stabilire tariffe che garantiscano loro un utile. In questo modo le tariffe si trasformerebbero in tasse. Ma, secondo D’Angelis, dato che «la maggior parte delle società che attualmente operano in Italia sono a maggioranza pubblica, gli utili finiscono nelle casse comuni, ritornando ai cittadini sotto forma di servizi migliori». Chi aderisce a questa posizione rileva, tra l’altro, che la manutenzione delle reti idriche anche non in situazioni di emergenza è estremamente costoso, e che le banche si dimostrano molto restie a concedere prestiti a soggetti pubblici. Banche che, tra l’altro afferma D’Angelis, «hanno già sospeso i finanziamenti alle nostre società in attesa dei risultati referendari, ponendoci in una situazione estremamente difficile».
Anche per il ministro dell’ambiente Stefania Prestigiacomo, intervenuta al convegno, il referendum sull’acqua è «un’iniziativa inutile e demagogica, adoperata in maniera strumentale da alcune forze politiche dell’opposizione».
ACQUA: E’ il problema del tubo
di Nicola Salvagnin
Tutti a parlare di acqua, in vista del doppio referendum del 12 e 13 giugno, e pochi a disquisire sul vero problema dell’acqua in Italia: un problema del tubo. Già, perché sono gli acquedotti a… far acqua in varie parti della penisola, tanto che si stima una perdita media dai serbatoi e dalle fonti fino ai rubinetti di circa il 45%, un colossale fiume che si disperde a causa di vecchie reti e di prelievi illegali. Un fiume che è stato valutato sui 2,5 miliardi di euro all’anno. La realtà quindi parla di 320 mila chilometri di condutture più da rottamazione che da modernità; di un 20% di italiani che non hanno fognature nelle quali far convogliare i reflui; di un Mezzogiorno in cui troppo spesso l’acqua non arriva al rubinetto o, comunque sia, ha problemi di potabilità. Quindi la vera questione, economicamente parlando, è quella del rinnovo (o della costruzione ex novo, laddove manca) della rete acquedottistica, per importi calcolati in decine di miliardi di euro. Una cifra spaventosa, totalmente fuori dalla portata dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Tanto per capire come stiamo affrontando questa emergenza, si calcoli che attualmente gli investimenti nelle reti non superano i 700 milioni di euro l’anno…
È soprattutto per questo che il decreto Ronchi, bersaglio di due referendum, aveva fortemente aperto agli investitori privati. In cambio, la gestione del ciclo idrico integrato che prevede la fornitura dell’acqua, lo smaltimento fognario e la depurazione; e una remunerazione del gestore non inferiore al 7% di quanto investito. Parlando terra terra: qualcuno i nuovi acquedotti li dovrà pur pagare. O lo fa l’ente pubblico tramite la fiscalità, o lo fa il cittadino tramite il pagamento di una bolletta inevitabilmente destinata a salire. Anche perché il costo dell’acqua in Italia è tra i più bassi d’Europa, meno di un terzo di quello tedesco.
Siamo in mezzo ad un gigantesco equivoco: l’acqua è un bene comune in tutto e per tutto? O un’utility come il gas e l’elettricità? Un equivoco nato dalla Legge Galli del 1994, che la riconosce come bene comune ma che impone l’integrale copertura dei costi sostenuti per portare l’acqua nelle case. Non si può fare un servizio «in perdita», come per esempio nel trasporto pubblico locale. Quindi l’acqua già la paghiamo (poco più di un euro per mille litri erogati) in Toscana più del doppio che in Val d’Aosta e gli investitori privati già ora gestiscono alcune reti acquedottistiche o sono nel capitale di società a prevalente proprietà pubblica. Il vero problema è: chi paga la sostituzione del colabrodo?
La soluzione è quella di migliorare le inefficienze territoriali, o scardinare l’intero sistema attuale a macchia di leopardo? Il governo ha scelto la seconda strada, fors’anche perché le «inefficienze territoriali» continuano a non migliorarsi; ora l’intera questione finisce al vaglio dei cittadini tramite l’istituto referendario.
Tra i referendum del 13 giugno ce n’è uno dedicato alla legge sul «legittimo impedimento», quella legge che consente al presidente del consiglio e ai ministri, nell’astratta ipotesi che siano imputati in un procedimento penale, di non presentarsi all’udienza e di farla slittare, nel caso in cui abbiano da fare per la loro attività di governo.
Quando la legge fu approvata ci furono grosse polemiche, perché invece di un’ipotesi astratta, il premier di processi ce ne aveva per davvero, e più d’uno. Sicchè pareva chiaro trattarsi di una legge ad personam. Di per sé la regola che quando un imputato è impedito di comparire il processo non si può fare e va rinviato è già scritta nel codice e vale per tutti, ed è sacrosanta, perché il diritto di potersi difendersi è un pilastro della giustizia; però l’impedimento, secondo il codice, deve consistere in una «assoluta impossibilità di comparire». Invece per il premier e per i ministri il criterio di impedimento consisterebbe nel «concomitante esercizio di una o più attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti», «delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività coessenziale alle funzioni di governo». Insomma tutto, o quasi tutto, il daffare. Di fronte alla pregnanza politica di questa legge, che per i suoi fautori promuoveva «la serenità nel governare», la raccolta di firme per abrogarla ha avuto subito un significato politico opposto, di non farla passar liscia alla furbizia dei potenti in cerca di privilegi, perché la legge è uguale per tutti.
Oggi la legge, però, non è già più quella di prima. La Corte costituzionale è intervenuta e l’ha sfrondata, ridimensionata. Ha soppresso la norma che attribuiva al premier il potere di attestare un impedimento continuativo; ha restituito ai giudici la funzione di valutare se l’impedimento c’è o non c’è, se è serio o pretestuoso. Insomma, l’ha un po’ svuotata, le ha tolto il pungiglione. E così, la legge adesso ha un profilo diverso, al punto che si è dubitato se il referendum dovesse ancora farsi o no.
È stato deciso che si farà. E se vincerà il sì, quel che resta della legge sarà cancellato, e il premier e i ministri saranno trattati come tutti gli altri. Se vincerà il no, quel che resta della legge sarà confermato, e gli impedimenti occasionati dall’attività di governo avranno peso, fermo restando il controllo del giudice. Io non ci vedo una gran differenza giuridica finale, se si intende che le regole vanno comunque applicate col buon senso, e l’uguaglianza non esclude l’attenzione alle differenze concrete delle situazioni soggettive (ognuno può avere impedimenti, per così dire, personalizzati, e il giudice deve avere l’intelligenza di capirli e di pesarli comunque). Ci vedo invece una differenza politica, questa sì, con la sua assorbente simbologia, con le sue ostentate bandiere. Un segnale di battaglia, una conta tra i fautori e gli ostili, verso il noto personaggio.
Che malinconia, di nuovo, trovarci ridotti al miserello bivio, quando il problema è la giustizia. Delle leggi, dei processi, del Paese.
CENTRALI NUCLEARI: Quell’atomo che spaventa, specie dopo Fukushima
La Cassazione ha deciso che il 12 e 13 giugno si voterà anche sul terzo quesito, quello sulla costruzione delle centrali nucleari. Il governo Berlusconi aveva cercato di cancellare questa consultazione, con l’approvazione definitiva, lo scorso 25 maggio, del «decreto omnibus», che ha abrogato le norme sottoposte a referendum, contenute nella legge n. 99/2009 (quella che aveva riaperto la strada al nucleare, conferendo la delega al governo) e nel decreto legislativo n. 31/2010 (quello sulla localizzazione e realizzazione delle centrali).
Il governo Berlusconi, che tanto aveva scommesso sulla ripresa del programma atomico, fermatosi in Italia dopo la vittoria degli antinuclearisti al referendum del 1987, già era in difficoltà a concretizzarlo per la indisponibilità di quasi tutte le regioni ad ospitare i nuovi impianti. Poi è arrivato lo tsunami giapponese e l’incidente alla centrale di Fukushima, facendo calare al minimo storico i favorevoli ai nuovi impianti. Da qui la decisione di lanciare prima una «moratoria», con il decreto legge n. 34/2011, e poi la cancellazione dell’intero programma.
Il comitato promotore, costituito da «Italia dei Valori» e da alcune associazioni ambientaliste, ha chiesto però di votare lo stesso, ritenendo la «rinuncia» del governo al nucleare solo «fittizia». Il comma 8 dell’art. 5 prevede infatti che la decisione se costruire centrali nucleari è affidata al «piano energetico nazionale» che sarà adottato «entro 12 mesi» dal consiglio dei ministri, dopo aver sentito il parere del parlamento. In sostanza, non servirà nemmeno una nuova legge: basterà un semplice atto amministrativo.
Il 1° giugno la Corte di Cassazione, accogliendo le istanze presentate dai promotori, ha ammesso il quesito referendario sul nucleare per il referendum del 12 e 13 giugno. La richiesta di abrogazione rimane la stessa, ma invece di applicarsi alle precedenti leggi (legge n. 99/2009 e decreto legislativo n. 31/2010) si applicherà alle nuove norme sulla produzione di energia nucleare (art. 5 commi 1 e 8 del decreto 34/2011, il cosiddetto decreto «omnibus»).
LA SCHEDA
Il referendum è uno strumento per l’esercizio della sovranità popolare, sancita all’articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. L’esito referendario è una fonte del diritto primaria che vincola i legislatori al rispetto della volontà del popolo.
Sono quattro le consultazioni referendarie previste dalla Costituzione: il referendum abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (articolo 75), quello sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (articolo 138), quello riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (articolo 132 comma 1), quello riguardante il passaggio da una Regione ad un’altra di Province o Comuni (articolo 132 comma 2). Inoltre è previsto che gli statuti regionali regolino l’esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione.
Nel 1989, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, si è votato anche per un referendum consultivo sul rafforzamento politico delle istituzioni comunitarie.
Altri referendum a livello comunale e provinciale sono poi previsti da fonti sub-costituzionali.
Il 12 maggio 1974 si svolge il referendum per l’abrogazione della legge Fortuna-Baslini, con la quale è stato introdotto in Italia il divorzio. L’affluenza è dell’87,7% e il tentativo di abrogazione fallisce. Sono i radicali a sfruttare la nuova «arma» che punta minacciosa al sistema dei partiti. L’11 giugno 1978 si svolgono altre due consultazioni: ordine pubblico e finanziamento dei partiti, per ambedue il quorum è raggiunto (81,2%). Nella primavera 1981 si vota su cinque referendum: ordine pubblico, ergastolo, porto d’armi, aborto (proposti dal partito Radicale e dal Movimento per la vita). Il quorum è raggiunto con il 79,4%.
La fase dei referendum sembra esaurita, si riapre nel 1985 con uno scenario completamente mutato. Il Pci, finora ostile all’uso del referendum, raccoglie le firme per l’abolizione della legge che taglia tre punti di contingenza proposta dal governo Craxi. Si vota il 9 e 8 giugno, vota il 77,9% degli aventi diritto. Vince il «no», un esito che pone fine alla centralità del sindacato, emerge la crisi del Pci. Dura pochi mesi la quiete referendaria, rotta dalle consultazioni su giustizia e nucleare. L’8-9 novembre 1987 si vota per cinque referendum (responsabilità civile dei giudici, commissione inquirente e tre sul nucleare). Vincono per la prima volta i «sì», come richiesto dai promotori. Cala al 65,1 il quorum dei votanti.
Il referendum consultivo sul Parlamento europeo del 1989 è quasi dimenticato; eppure, segna un passaggio importante nella storia delle consultazioni referendarie.
Senza storia la consultazione sulla disciplina della caccia del giugno 1990 che tocca il minimo storico degli aventi diritto (43,4%). Avrà tutt’altra sorte il referendum del 9 e 10 giugno 1991 sulla riduzione delle preferenze per la Camera dei deputati: il quorum è raggiunto (62,5%), sconfiggendo la strategia di Craxi («meglio andare al mare»). La quasi totalità dei votanti dice «sì» (95,6%). Nella stagione dei referendum a «raffica» si affaccia un altro grande protagonista: la Corte Costituzionale che assume un ruolo di supplenza alle carenze del legislatore, limitando e selezionando le consultazioni richieste. Il 18 e 19 luglio 1993 gli elettori sono alle prese con otto schede con i quesiti più disparati: dal finanziamento pubblico dei partiti alle nomine nelle casse di risparmio. Il quorum (77%) è raggiunto nonostante il comprensibile sconcerto dell’opinione pubblica. Due anni dopo, 11 giugno 1995, le schede salgono a dodici. I quesiti spaziano dalla concentrazione di tre reti televisive al soggiorno cautelare per gli imputati del reato di mafia. Questa volta il quorum è raggiunto a fatica (58,1%). Un risultato quello del giugno ’95 che resta una pietra miliare nella storia dei referendum in Italia: il quorum del 50% più uno non sarà più raggiunto nelle consultazioni del 1997, 1999, 2000 e 2003. È la «regola del 20 per cento», anziché convincere a votare «no» il 30-40% degli elettori si punta a una scorciatoia: persuaderne un numero minore a non andare a votare. Da allora non ha più fallito.