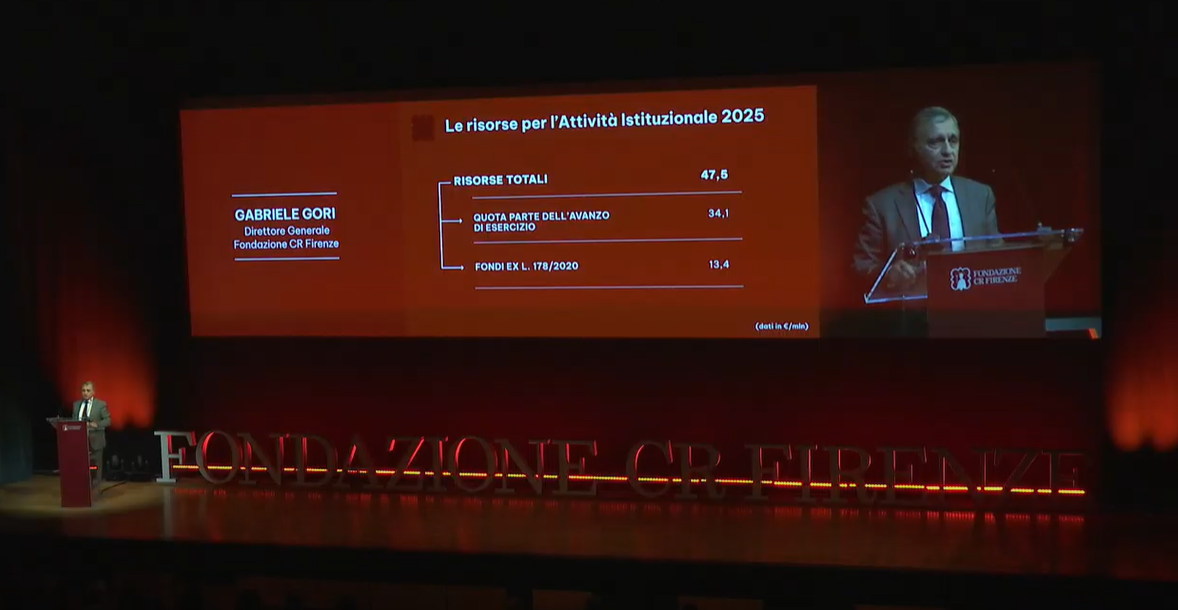Italia
Stragi Capaci e via d’Amelio. Don Rattoballi: «Una ferita ancora aperta e tanto cammino da fare per vincere la mafia»

Ci sono date che segnano un prima e un dopo. Ci sono date che non si possono dimenticare. Ci sono date che consegnano alla storia delle persone che hanno creduto nello Stato, nella giustizia, nell’onestà e sono diventate simboli di un riscatto, che, però, non è mai compiuto del tutto, ma che chiede ogni giorno nuovo impegno perché la mafia è davvero una piovra tentacolare sempre pronta a riemergere, approfittando delle difficoltà in cui si dibatte la società, acuite dalla crisi. Il 23 maggio e il 19 luglio 1992 sono date che nessuno può dimenticare: nella prima avvenne la strage di Capaci, nella quale furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio MontinariPaolo Borsellino e cinque agenti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. A ricordare al Sir quei tragici eventi è don Cesare Rattoballi, parroco dell’Annunciazione del Signore a Palermo, cugino dell’agente Vito Schifani e amico della famiglia Borsellino.
Don Cesare, sono passati venticinque anni dalla morte di Falcone e Borsellino: è una ferita ancora aperta?
«La morte di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino è stata una ferita non solo per la Sicilia, ma per tutta l’Italia e non solo. Mi ricordo che quando venne in Italia il responsabile della Cia, che era amico di Falcone, disse che con la sua morte c’era stata una grande perdita a livello internazionale. E, oggi, dopo venticinque anni, è ancora una ferita dolorosissima per tutti».
I due giudici sono diventati un simbolo di riscatto…
«Dopo la morte di Falcone a Palermo si sono organizzate tantissime manifestazioni e sono nate tante realtà, come il Comitato dei lenzuoli. Questo processo di risveglio delle coscienze è stato ancora più forte dopo la strage di via d’Amelio, in cui persero la vita il giudice Borsellino e la sua scorta. Non a caso, ogni anno in occasione dell’anniversario della strage di Capaci arriva una nave o un treno di ragazzi che vengono a ricordare quanto è accaduto ma anche a proporre un discorso di legalità».
Cosa è necessario?
«È un discorso più globale. Ci sarebbero anche delle leggi da fare, bisognerebbe promuovere la famiglia, il lavoro perché lo Stato molto spesso si dimentica delle periferie e delle famiglie che non hanno lavoro. Bisognerebbe tenere impegnati i padri e le madri di famiglia per evitare che siano tentati di imboccare le scorciatoie della delinquenza, che poi aprono le porte alla criminalità di stampo mafioso. Dobbiamo ancora insistere: abbiamo un’importante eredità, abbiamo la testimonianza viva di questi due magistrati, insieme agli uomini di scorta, ma la situazione è molto complessa. Non è tutto o bianco o nero».
Che ricordo ha di suo cugino Vito?
«Era un ragazzo molto sportivo, spensierato, allegro, aveva realizzato il suo sogno: si era sposato e aveva un bimbo di quattro mesi. Vito avrebbe dovuto prendere servizio presso la Polizia di Stato come pilota di elicotteri perché aveva vinto il concorso interno e doveva essere trasferito a Roma ai primi di giugno. Ci è stato strappato con crudele violenza».
Venticinque anni fa, durante i funerali, colpirono moltissimo le parole che pronunciò la moglie di Vito, Rosaria Costa, rivolgendosi ai mafiosi: «Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio, se avete il coraggio di cambiare…». Quell’appello alla conversione ha sortito qualche effetto?
Cosa la colpiva in Borsellino?
«La sua genuinità. Metteva le persone a proprio agio. Era una persona molto di cuore, sensibile, con grandi qualità dal punto di vista umano, professionale e cristiano, amava la verità, la sua famiglia e lo Stato italiano. Una volta, prima di confessarsi, mi disse che era arrivato il tritolo per lui, ma non si è tirato indietro».