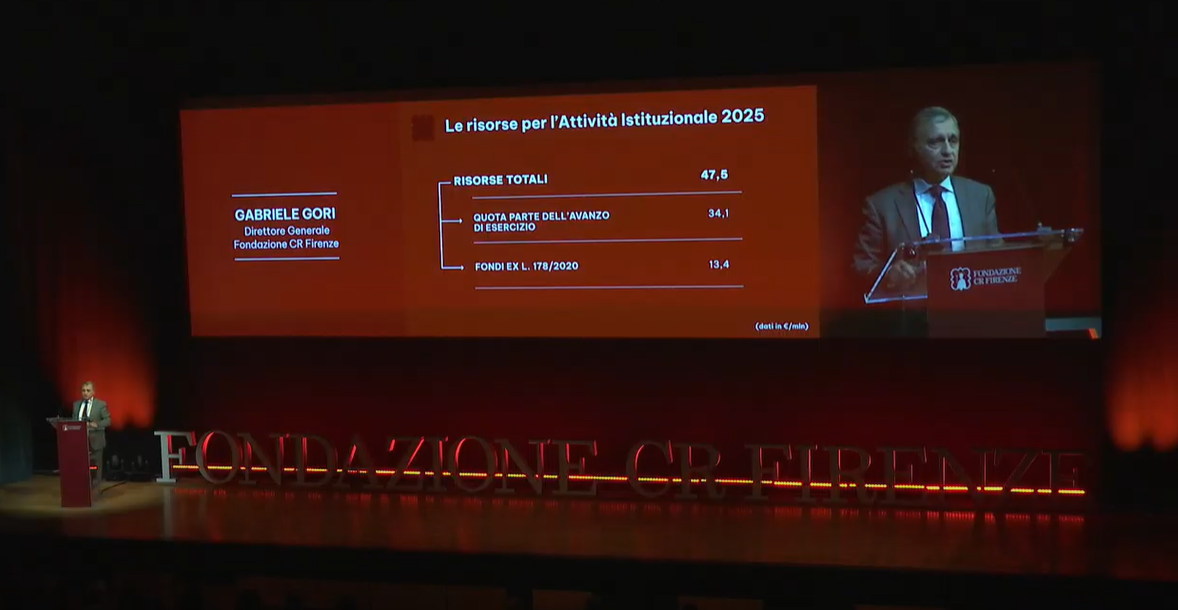Italia
Due toscani tra le macerie di Gaza

di Simone Pitossi
Sono stati i primi due cooperanti italiani ad entrare nella Striscia di Gaza a fine gennaio, dopo l’intervento militare israeliano. Si tratta di Daniela Riva (nella foto, con i bambini di Gaza) e del fiorentino Fabio Pierini. Daniela, 31 anni, è la capoprogetto a Gaza. Fabio, 40 anni appena compiuti, segue anche un altro progetto in Cisgiordania (se ne parla nell’articolo a fianco). E a Gaza sono sempre gli unici italiani: solo un altro operatore umanitario è riuscito ad entrare. I due collaborano con l’organizzazione non governativa bolognese Gvc e nella Striscia si occupano di alcuni progetti: il sostegno alla Banca del sangue (in questo momento molto sotto pressione), la ricostruzione di condutture idriche e fognature, i pozzi d’acqua. Il fiore all’occhiello, in questo momento, è un desalinizzatore che servirà a dare acqua potabile ad almeno 20 mila persone. «L’impianto ci raccontano i due in collegamento telefonico dall’ufficio di Gaza City era pronto a Gerusalemme dal novembre scorso e i lavori per prepare l’impianto erano già stati avviati. Il blocco prima e l’intervento militare poi hanno bloccato tutto».
E ora a che punto siete?
«Quando siamo entrati a fine gennaio abbiamo fatto la conta dei danni insieme ai nostri tecnici palestinesi. Poi abbiamo rimesso in moto i lavori. Finalmente a fine febbraio siamo riusciti a portare nella Striscia il desalinizzatore. Per fine aprile pensiamo di riuscire ad inaugurare l’impianto che fornirà acqua potabile al campo profughi di al-Bureij che ospita oltre 20 mila persone».
Le prime impressioni quando siete rientrati a Gaza?
«Mancavamo da novembre, quando le autorità israeliane hanno chiuso la frontiera. Prima di rientrare avevamo visto alcune immagini della distruzione. Ma quando siamo entrati ci siamo resi conto della situazione: macerie ovunque. Ad accoglierci dopo il valico di Eretz un nostro collaboratore palestinese che, come gli altri sette, è rimasto a Gaza sotto le bombe. Alcuni di loro hanno dovuto abbandonare le case. La Striscia è un corridoio di terra strettissimo dove vivono oltre un milione e mezzo di persone. Non si può scappare, non si può cercare rifugio. L’unica soluzione è chiudersi in casa e sperare che non venga bombardata. I danni più gravi non sono stati quelli provocati dagli attacchi aerei ma quelli dell’offensiva di terra: i bulldozer hanno spianato la strada ai carrarmati che poi hanno raso al suolo interi villaggi».
Il vostro ufficio a Gaza ha subito danni?
«No, per fortuna. Ma all’entrata della stazione dei pompieri, proprio di fronte a noi, c’è un cratere provocato da un missile. Le strutture danneggiate però sono tante. Per esempio all’ospedale della Palestinian Red Crescent Society è stato semidistrutto il secondo piano. E poi la vicina centrale di polizia: è stata spazzata via. Dalla finestra del nostro ufficio si vede il porto: le barche erano state colpite e affondate».
E la situazione delle persone com’è?
«Disastrosa. I dati ufficiali parlano di 1440 persone uccise e 5380 ferite. Ma sono almeno 20 mila le case completamente distrutte e tante le famiglie senza un tetto. Manca di tutto: materasse, coperte, vestiti. Poi c’è la questione dell’acqua potabile: era un problema prima, figuriamoci adesso. Nei sopralluoghi al nostro rientro alcune famiglie ci hanno detto di avere acqua corrente solo per un ora al giorno e di non essere in grado di stoccarla perché le cisterne sono state danneggiate. E poi ci sono quelli che non hanno più una casa e vivono in tende di fortuna. Ora la situazione sta lentamente migliorando: molti si sono rimboccati le maniche e hanno cominciato a ripulire e ricostruire. Ma c’è un’emergenza: la mancanza di cemento che le autorità israeliane non fanno entrare. Senza quello non si può lavorare e le scorte si stanno esaurendo».
Cosa pensano ora i palestinesi?
«Il morale è molto basso. Sono state colpite la maggior parte delle attività commerciali, in particolare quelle agricole che costituiscono la grossa fetta del reddito familiare. La disoccupazione è altissima e i bisogni sono tanti. Questo attacco è stato il peggiore di sempre. Poi c’è un certo fatalismo: è sempre stato così, le cose non cambieranno, dicono. E, infine, c’è come la sensazione che non sia finita qui, che stia per succedere qualcosa. Insomma, si aspettano il peggio».
L’olio palestinese parla fiorentino
Si chiama «Rameen blend». È il migliore olio palestinese. E parla fiorentino. Sì, perché chi segue il progetto da un anno è Fabio Pierini, laureato in agricoltura tropicale e subtropicale presso l’Università di Firenze. Nel suo «stato di servizio» molte situazioni di emergenza: nel 2003 in Afghanistan per supportare gli agricoltori e le famiglie di Kabul, poi nell’Indonesia post-tzunami, per finire nel sud del Libano dopo il bombardamento israeliano. Da aprile del 2008 si trova appunto nel nord della Cisgiordania per un progetto sull’olio extra vergine di oliva.
«Lavoro spiega con circa 200 olivicoltori di 9 villaggi tra Tulkarem e Nablus che si stanno costituendo in cooperative. Ho organizzato attività di formazione e assistenza tecnica sul terreno che hanno interessato tutte le fasi della filiera: dalla coltivazione degli oliveti, alla raccolta e spremitura delle olive, fino alla conservazione e al sostegno nella fase di negoziazione dei prezzi di vendita dell’olio». E così siamo arrivati alla premiazione del primo concorso palestinese, promosso dal programma di sostegno al settore olivicolo-oleario nazionale e cofinanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Emilia-Romagna.
Il premio «Golden Olive 2009» è stato consegnato all’olio estratto dalle olive degli agricoltori di Rameen (Tulkarem) dal capo della delegazione della Ue a Gerusalemme. E dal 2 al 6 aprile Pierini sarà a Verona al salone dell’olio per presentare il suo prodotto. «È il risultato di un lavoro sottolinea che abbiamo svolto anche grazie alla presenza di esperti italiani del settore che ci hanno aiutato a migliorare la qualità della produzione olearia, che, nelle aree rurali della Palestina, rappresenta la principale attività economica». L’olio prodotto viene già esportato anche all’estero: Giappone, Svizzera, Usa e Olanda.
«Stiamo lavorando per ottenere la certificazione per il mercato equo e solidale. Anche se dice con un certo orgoglio il cooperante il nostro obiettivo è quello di vendere il nostro olio non perché è palestinese ma perché è un buon prodotto». Non siamo a Gaza ma la situazione non è facile. «I nostri olivicoltori spiega come tutti gli altri in Palestina, vivono in condizioni difficili: poca libertà di spostamento, con i coloni degli insediamenti molto aggressivi. In uno dei nostri villaggi raccolgono il grano molto anticipatamente per paura che i coloni diano fuoco ai campi. Così come i danni agli olivi tagliati o bruciati». Non solo. «Gli insediamenti, illegali, continua si annettono un’area intorno, dicono per ragioni di sicurezza. In quell’area, anche piuttosto vasta, ci sono gli olivi dei palestinesi e per tutto l’anno l’accesso viene negato. Per cui le cure colturali dell’oliveto vengono a mancare. A spizzichi e bocconi, possibilmente con la scorta di volontari internazionali per evitare vessazioni e violenze, viene concesso l’accesso da mattina a sera per raccogliere le olive. Il problema è che io, che dovrei lavorare sulla qualità dell’olio, mi vedo costretto a rifiutare queste olive. Loro le spremono comunque ma l’olio che ne viene fuori è morchia».
E poi ci sono gli interventi militari a sorpresa. «Cercano supposti terroristi, perquisiscono case, arrestano gente. Tutto senza accuse precise: si chiama detenzione amministrativa e dura 4 mesi, rinnovabili. Pochi giorni fa gli israeliani racconta Pierini hanno fatto un’incursione notturna nel villaggio di Iktaba. Sono entrati nella casa di un nostro coltivatore e poi nel magazzino dove è stoccato l’olio in serbatoi di acciaio inox. Hanno aperto un rubinetto e fatto defluire una tonellata di olio, qualcosa come 4 mila euro di prodotto. Queste sono le violenze gratuite che qui accadono quotidianamente».