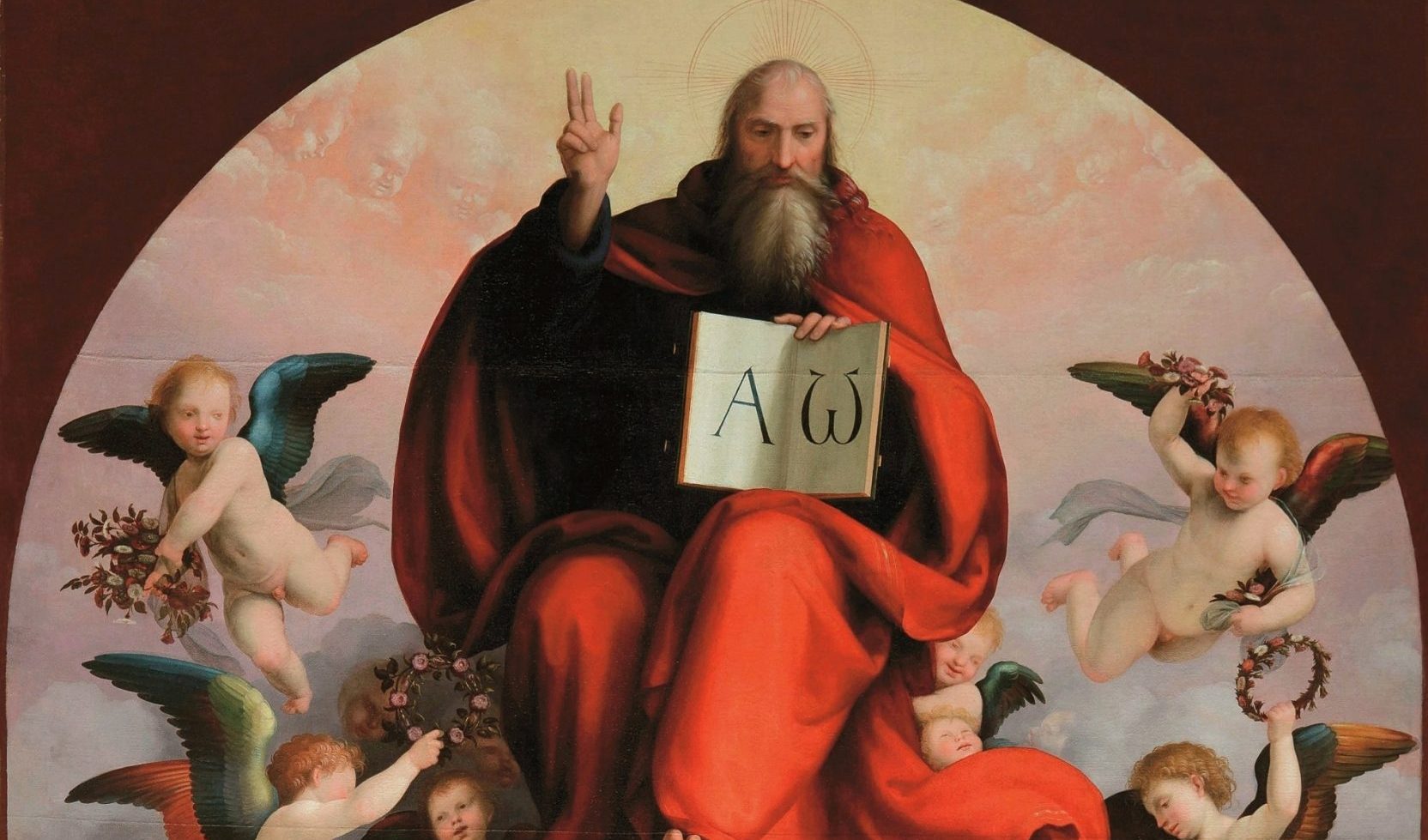LEBANON

DI FRANCESCO MININNI
«Anche io sono stato un carnefice». Le parole del regista Samuel Maoz, israeliano, premiato a Venezia con il Leone d’Oro e ben deciso a non nascondere il suo passato di soldato nella guerra del Libano del 1982, creano un interessante parallelismo con Ari Folman e «Valzer con Bashir»: entrambi soldati, entrambi toccati dall’urgenza di raccontare la loro storia per ricucire un pezzo del proprio passato.
Che nella guerra non ci fosse alcunché di romantico o bello, lo sapevamo da un pezzo. Ma un conto è affrontare l’argomento con realismo e crudezza, un altro entrarci semplicemente dentro e lasciare che le immagini vadano di conseguenza. «Valzer con Bashir» era una dolorosa seduta di autoanalisi alla ricerca del passato rimosso. «Lebanon» è una verità talmente allucinante che a un certo punto si ha l’impressione di trovarsi in un romanzo di Kafka (più «Il castello» che non «Il processo»). Perché Maoz ha avuto l’idea, giustissima, di raccontare la propria esperienza da un «dentro» che va oltre l’autoanalisi e, eccezion fatta per la prima e l’ultima inquadratura del campo di girasoli, non è mai uscito dall’interno del carro armato israeliano occupato da Assi, Shmulik, Hertzel e Yigal. Così ogni incontro, ogni paesaggio, ogni proiettile, ogni amico o nemico sono filtrati attraverso il mirino. Dal che si deduce che ogni cosa è un potenziale obiettivo del fuoco e, automaticamente, non può mai essere vista con occhi diversi, diciamo da turista. E da questo emerge un sentimento del quale forse non abbiamo una cognizione precisa: si chiama paura. Non paura di morire, o di un proiettile, o del nemico: paura di tutto.
In questo contesto i quattro ragazzi (perché di ragazzi si tratta, non va mai dimenticato) perdono progressivamente la loro identità di esseri umani e assumono il ruolo di pedine in un gioco le cui regole sono scritte da altri. E si capisce bene come non ci sia posto né per la commozione né per l’umana pietà né per la nostalgia di casa: c’è posto soltanto per la consapevolezza di un incubo che potrebbe non aver mai fine. È perfettamente inutile raccontare la storia di un film che prevede soltanto claustrofobia ed emozioni negative. Il sole che entra periodicamente dal portello della carro armato, aperto per far entrare o uscire qualcuno, sembra quasi un intruso. Nessuno dei ragazzi sembra aver voglia di andargli incontro, perché sa benissimo che un attimo dopo ripiomberebbe nell’oscurità.
Con rapidi tocchi Maoz fa capire che, meglio o peggio che sia, ci si abitua a tutto: alla sofferenza di chi, colpito, non è ancora morto, alla necessità di dover sparare su qualunque cosa si muova, a convivere con fango, orina, escrementi, birra, tutto mischiato insieme sul fondo del carro, alla prospettiva di un viaggio che ha un inizio ma potrebbe non avere una fine. Non nascondiamocelo: «Lebanon» è un film coraggioso, privo di qualunque indulgenza, consapevole dei mezzi e capace di creare una tensione psicologica che a tratti rischia di far mancare il respiro. E a chi dovesse invocare le ragioni della speranza diremmo semplicemente di fare qualcosa. Come Maoz, che per il fatto stesso di essere riuscito a raccontare l’irraccontabile si pone comunque nel numero di quelli che, pur vedendo il nero in cui viviamo, è anche convinto che si possa fare qualcosa per cambiarne la tonalità. Il fatto stesso dell’esistenza di un film come «Lebanon» è già una ragione di speranza. Il coraggio di mostrare un soldato israeliano che piange perché vuole tornare a casa, cosa per niente gradita in patria, è di per sé una ragione di speranza. Bisogna capire che la speranza non è un lieto fine che comporterebbe comunque la morte di qualcuno: è il saper vedere oltre anche nel momento in cui si raccontano morte e follia. È una semplice richiesta di aiuto.
LEBANON (Id.) di Samuel Maoz. Con Yoav Donat, Itay Tiran, Oshri Cohen. ISRAELE 2009; Drammatico; Colore