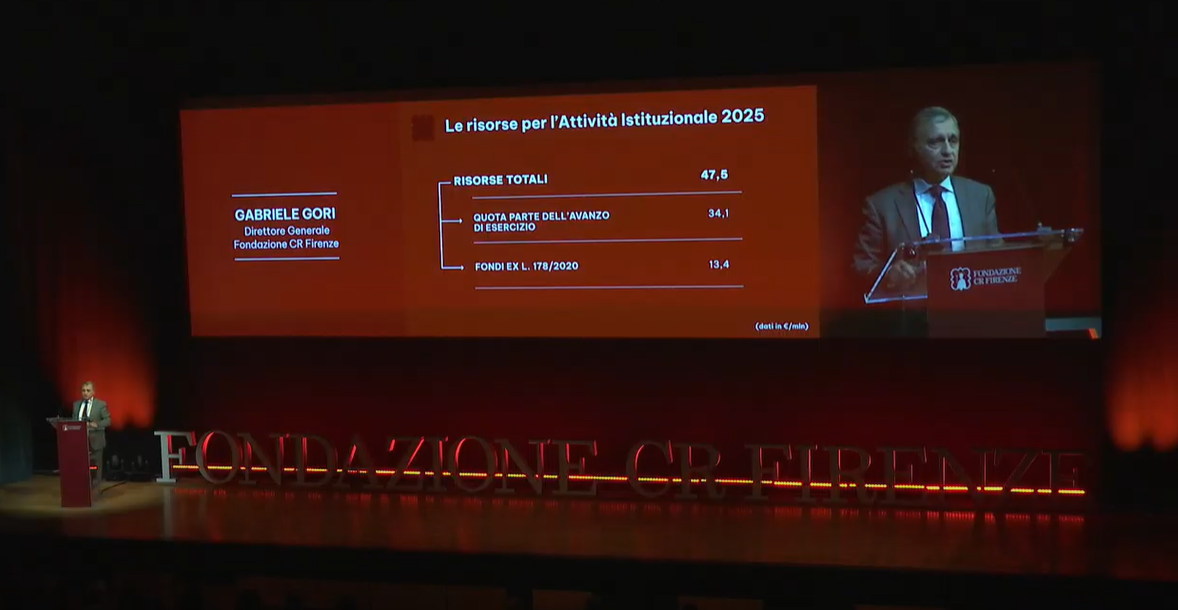Opinioni & Commenti
La lezione della storia, nelle grandi pestilenze la fede vinceva sull’indifferenza
«Ed ecco un cavallo di color pallido-livido, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli teneva dietro l’Inferno, e gli fu data potestà sopra le quattro parti della terra per uccidere colla spada, colla fame, colla mortalità e con le bestie feroci». Così nell’Apocalisse colui che viene tradizionalmente identificato con l’ormai vecchissimo evangelista Giovanni, il «Veggente di Pathmos», presenta il protagonista del quarto dei sette sigilli (Apocalisse, 6, 7-8). Dopo il cavaliere del cavallo candido, identificato con il Cristo, quello del cavallo rosso ch’è la guerra, quello del cavallo nero ch’è la carestia, il terribile cavaliere del cavallo pallido è una morte che uccide con ogni mezzo: la spada della guerra, la bilancia simbolo della penuria cioè della fame, ma anche con la «mortalità», vale a dire con una morte simultanea, collettiva, in apparenza inspiegabile.
A peste, fame, et bello – libera nos, Domine… È un’antica sequenza liturgica, una giaculatoria mèmore appunto del testo apocalittico e testimoniata nella storia appunto dal collegarsi caratteristico – in una «catena malthusiana» – dei tre grandi eventi luttuosi dei conflitti, dei periodi di carestia e delle esplosioni di malattie contagiose che si provocano e si sostengono a vicenda: la guerra porta su un territorio la presenza di genti ostili che portano violenza e distruzione (insieme con infinite occasioni di contagio), la penuria di mezzi di sussistenza che deriva dall’abbandono dei campi, dalla flessione delle consuetudini igieniche e dal disordine comporta la difficoltà di produzione e di trasporto delle derrate e il consequente lievitare dei loro costi e tutto ciò, con la caduta delle difese fisiologiche dei corpi debilitati dalla fame, favorisce l’impiantarsi di processi morbosi la meccanica della propagazione per contagio dei quali resta misteriosa e favorisce quindi tanto la nascita di leggende e di pregiudizi quanto l’insorgere di paure collettive. Ma va da sé che, come vediamo anche ai giorni nostri, un’epidemia può sorgere e propagarsi anche in almeno apparente mancanza di altri fattori: ciò la rende ancora più inspiegabile e tremenda.
Nell’antica litania il buon popolo cristiano pregava il Signore di tener lontani da lui una serie di flagelli, dalle tempeste alle invasioni delle locuste alle incursioni normanne o saracene («mamma li turchi»): i «quattro cavalieri dell’Apocalisse», la guerra, la fame, la peste e infine la morte, esito fatale delle altre tre. In effetti, come ha insegnato anche la storiografia moderna da Michel Mollat a Jean Delumeau, fra esse si stabiliva una tragica concatenazione. Era spesso il passaggio degli eserciti a recare ai popoli dei territori da loro attraversati qualche tragica malattia contagiosa; inoltre i saccheggi e le rapine alle guerre connessi comportavano la fame, e sugli organismi da essa indeboliti s’insediava il morbo. Ma non era nemmeno necessaria la guerra: nella lunga età preindustriale del mondo le carestie erano ricorrenti: e su corpi malnutriti e igienicamente trascurati i germi o i virus prosperavano.
Nella storia generale dell’umanità, si è usi ricordare come «pesti» alcuni grandi flagelli d’origine in realtà eterogenea: dalle «pestilenze» ricordate dalla Bibbia a proposito delle «piaghe d’Egitto» o dell’epidemia che decimò l’esercito dei filistei dopo che essi si furono impadroniti dell’Arca dell’Alleanza fino alla grande «peste» di Atene del 429 a.C., descritta da Tucidide, e ancora alla «peste» di Roma del 66 d.C. di cui ci ha parlato Tacito, a quella scoppiata nel II secolo d.C. (la «peste antonina») dinanzi alla quale fuggì anche il grande medico Galeno, sino alla «peste di Giustiniano» sulla quale c’informa Procopio da Cesarea relativamente all’anno 542, quand’essa giunse a Costantinopoli, a quella del 1347-50 da cui parte appunto il «Decameron» del Boccaccio fino a quella del 1630,della quale com’è noto diffusamente tratta il Manzoni nel saggio storico su «La colonna infame», oltre che – naturalmente – ne «I promessi sposi». Nei casi descritti da Tucidide e da Galeno si tende oggi a ritenere che si trattasse piuttosto di epidemie di vaiolo. Il progresso delle ricerche storiche e antropologiche degli ultimi due secoli ci consente di affermare che, in questi casi e in altri, si sia trattato di autentiche «pandemie», vale a dire d’infezioni epidemiche diffuse in tutto il mondo e in tutto il genere umano, anche se differenti per gravità e durata. È quasi impossibile che un’epidemia venga debellata del tutto: in genere perde d’intensità, si nasconde, sopravvive a livelli «endemici» salvo magari riaffiorare con mutati caratteri.
Noi parliamo di solito, per il passato, di «peste», «pestilenza»: ma sono termini vaghi, imprecisi. Già tra le peste polmonare, quella setticemica e quella ghiandolare, la «bubbonica», caratterizzata dai linfonodi ingrossati e dolenti, c’è per esempio una bella differenza. Si tratta di affezioni del tutto diverse; il che non vuol dire che non possano presentarsi assieme, come difatti accadde nell’epidemia del 1347-50: la peste bubbonica viene inoculata attraverso il morso della pulce che è portatrice del relativo bacillo, quella polmonare si trasmette da uomo a uomo.
Quel che comunque colpisce quando una società è colpita da una malattia epidemica, in qualunque società e in qualunque tempo, è il suo caratteristico iter. Il contagio si manifesta sulla prima in maniera incerta e sporadica, e si tende a sottovalutarlo o a negarlo. Poi, mano a mano che si diffonde, si genera nelle arre limitrofe ai luoghi dove si presenta un’ansia sempre maggiore, che può giungere a livelli d’isteria collettiva. In questi casi succede di tutto: gli ammalati vengono fuggiti e lasciati senza cure oppure fatti segno di violenze in quanto ritenuti responsabili della loro affezione; si passa poi facilmente a teorie più o meno complottistiche (gli «untori», le streghe o i malfattori assoldati da potenze nemiche i quali «ungono le porte» o «avvelenano i pozzi» eccetera). L’esperienza – empirica prima, scientifica poi (in Europa dal XVIII secolo) – insegna a difendersi: e allora alla farmacopea tradizionale fatta di solito di unguenti e polveri «odorose» atte a «purificare l’aria» succedono i fàrmaci efficaci. Teoria scientifica, ricerca clinica ed esperienza, alleati, finiscono col battere il contagio: anche se con inevitabili danni.
E i risultati? Sulle prime il contagio ha effetti deleteri sia civili sia socioeconomici; poi s’impara a sfruttarlo, spesso anche disonestamente (i sani rapinano gli ammalati, i superstiti s’impadroniscono delle ricchezze e delle eredità dei defunti); infine, magari nelle «medie» o «corte» durate, affiorano anche i lati positivi di tipo strutturale: dalle epidemie si esce immunizzati e irrobustiti, i vuoti lasciati nelle società dai decessi procurano nuovi lavori e abbassano i costi di certi beni specie immobili procurando ricchezza, la terra lasciata riposare a causa della rarefazione degli agricoltori torna a produrre in modo ferace. Insomma, come al solito, non sempre e non tutto il male viene per nuocere. La ricetta, in fondo, è sempre la stessa: se si è sani, cercar di evitare le occasioni di probabile contagio; se si è ammalati, far di tutto per guarire. Come al solito, il pericolo maggiore e il danno peggiore è la perdita di lucidità mentale, di razionalità, di coraggio, di speranza. Tutto passa. Vedrete che passerà anche il coronavirus, pur ammesso che davvero sia la peste del XXI secolo. Ricordate la SARS? Pareva la fine del mondo, ma si rivelò poco più che un’influenza.
Ma dinanzi al pericolo epidemico si reagisce oggi in forma più adeguata che nel passato, oppure «si stava meglio quando si stava peggio»? Indubbiamente il progresso nella scienza e nella capacità d’informazione e di reazione socioprofilattica oggi è incommensurabilmente migliore di prima, specie dopo «l’impennata» scientifico-sanitaria e socio-sanitaria degli ultimi decenni. Quel che c’è semmai da dire rispetto ad esempio alla «società tradizionale» premoderna, diciamo che – limitandoci all’Europa un tempo cristiana, oggi postcristiana e «secolarizzata» – un tempo dinanzi ai flagelli si reagiva «teatralizzando» e quindi «addomesticando» la morte, presenza inevitabile nella vita dell’uomo e parte della vita stessa: la fede insegnava a non assolutizzare il pericolo, a sperare nella misericordia divina o nella vita eterna. Oggi, in un tempo nel quale si fa di tutto per convincersi istericamente di «aver diritto» alla vita e alla felicità e che si ambirebbe a divenire non solo immortali, ma addirittura «eternamente giovani» in quanto è diffusa convinzione che al di là dei valori materiali dell’esistere non vi sia altro, dinanzi al pericolo s’è solo il pànico: o si «nega» la morte dissimulandola o nascondendola, oppure ci si abbandona alla disperazione e alla caduta generalizzata della solidarietà. Questi i pericoli postmoderni dai quali bisogna guardarsi. Il punto non è che, in tempo di contagio, sia meglio non stringere più la mano ai nostri interlocutori: quel che non si deve fare è non riconoscersi più negli altri, negar loro soccorso e solidarietà. Ha ragione come al solito papa Francesco: il peggior peccato al mondo è l’indifferenza: quando poi essa si tinge di paura egoistica, siamo alla perdita totale della dignità umana. Da ciò dobbiamo guardarci.