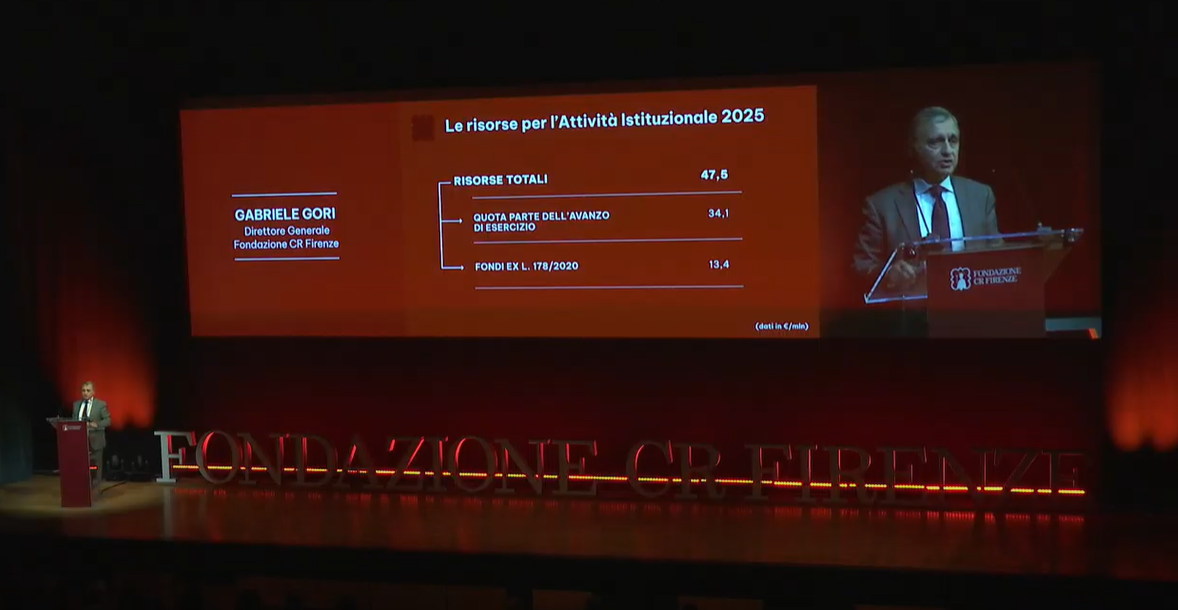Opinioni & Commenti
Gli scenari che si aprono con l’elezione di Trump
«Our country, right or wrong»: a torto o a ragione è il mio paese. La vecchia frase pronunciata due secoli fa dal capitano di vascello Stefen Decatur è diventata il simbolo dell’America tante volte detto e ripetuto, il dovere quasi cieco secondo cui la nazione viene prima di tutto e al sentimento di patria, alla totalità degli americani rappresentata dalla sacra bandiera a stelle a strisce, si possono sacrificare perfino le proprie convinzioni e i propri sentimenti.
Ma ora il ciclone Trump sembra aver rimesso in discussione anche questa famosa unità e lealtà nazionale, la religione suprema della patria che permette, secondo la famosa definizione di Diana Johnstone, di tenere insieme anche il grande mosaico delle infinite religioni del paese. Oggi metà del paese scende in piazza contro l’altra metà per una di quelle contestazioni che negli Usa, quando finalmente scoppiano, durano non giorni, ma almeno mesi. E la frattura ora non si ripete fra nord e sud e nemmeno fra bianchi e neri. È un sisma che viene dallo scontro profondo di tante faglie diverse e per questo anche potenzialmente più devastante e più difficile a riassestarsi in un nuovo equilibrio. È una contrapposizione che già nella campagna elettorale ha fatto scendere in campo tutti gli opposti, fra uomo e donna, fra plebe ed élite, fra ieri e domani.
E lo scontro continua fra l’America bianca tradizionale e l’America multiculturale delle infinite minoranze dei neri, degli ispanici, dei musulmani, delle varie sessualità. Fra la periferia di «destra» e la città di «sinistra», fra la povera Louisiana che vota Trump e la ricca New York che vota Clinton. Fra la «old economy», la vecchia economia manifatturiera che Trump vorrebbe far resuscitare e la «new economy», la nuova economia digitale delle grandi multinazionali che fra l’altro hanno in mano tutti i media del paese. Fra la nostalgia della vecchia industria siderurgica e automobilistica coccolata con le protezioni doganali e la mondializzazione voluta da imprese multinazionali che per il lavoro che fanno non possono che essere senza confini nella loro proiezione monopolistica a livello planetario. Fra chi vuole tornare a privilegiare l’America bianca di stampo anglosassone e possibilmente protestante, con un «C’era una volta l’America» contrapposto a chi negli ultimi venti anni ha pensato di fare del Nuovo continente, proprio in virtù della sue storia di emigrazione, l’esempio più importante di un multiculturalismo che raccoglie e accoglie da tutto il mondo e da tutte le culture.
È augurabile che un presidente che ha tanti poteri trovi nella necessità di ridare una normalità al paese un motivo per moderare o almeno limare i suoi propositi preelettorali, per dimostrare che il Trump che ha vinto è un po’ più clemente almeno del Trump della battaglia elettorale, anche se un appello populista rivolto direttamente alla gente senza la mediazione delle istituzioni e dei partiti non si può smentire facilmente. Del resto non solo l’America, ma il mondo intero davanti a Trump sembra oggi in sostanza farsi la domanda che facciamo a quattrocchi a chi l’ha sparata grossa. «Ma davvero fai sul serio?».
E ci si attacca non solo alle mezze frasi, ma perfino ai silenzi di Trump nella speranza che la sicurezza di andare a dormire alla Casa Bianca lo renda ora un po’ più sedato o per lo meno più mansueto. In questo bisogno generale di conforto di un certo buon auspicio sono sembrati alcuni accenni fatti dal neopresidente nella sua intervista al Wall Street Journal. Sembra che sia tramontata l’idea di mettere sotto inchiesta la Clinton. Perfino qualcosa del sistema di sicurezza sociale Obamacare potrebbe essere salvato. È sparita l’idea di rifiutare l’ingresso negli Usa ai musulmani in blocco. Ma pochi giorni dopo, in una intervista alla Cbs, ecco riapparire l’espulsione degli immigrati, anche se non si tratterebbe degli undici milioni di irregolari, ma dei tre milioni che avrebbero commesso reati. E rifà capolino perfino il famigerato muro con il Messico, anche se è più facile promettere che costruire una barriera di 1.600 chilometri. Rimangono in piedi in sostanza tutti i propositi più importanti fra cui il disinteresse verso l’Europa, la guerra commerciale con la Cina, il riavvicinamento a Putin e attraverso Putin in pratica anche ad Assad, la fine di ogni misura contro il riscaldamento globale del pianeta, il rifiuto o la rinegoziazione di tutti i trattati di libero scambio perno della globalizzazione.
In questo quadro la più preoccupata sembra essere proprio l’Europa. Le proposte che gli europei si paghino la Nato se la vogliono, che non ci si affidi agli Usa per garantire i paesi dell’Europa Orientale, che con Putin si deve andare d’accordo, gettano nel panico chi non ha mai pensato sul serio ad una propria difesa e non ha mai cercato di dialogare con il leader russo anche se una distensione in questo senso potrebbe portare il beneficio della riduzione delle sanzioni.
Con la Cina, il cui presidente è stato quasi l’unico a non fare gli auguri a Trump, le cose sembrano mettersi ancora peggio. Trump, mettendo i dazi alle merci cinesi e promettendo ancora di metterli sottoaccusa per la presunta svalutazione dello yuan, dovrà accettare anche la reazione uguale dei cinesi. E non è detto che in questa battaglia Trump sia il più forte. Mentre promette di aumentare gli investimenti e di ridurre le tasse con l’aumento del debito pubblico il neopresidente fa finta di non sapere che il debito americano è quasi tutto in mano ai cinesi.
Nel Medio Oriente, oltre all’abbandono al loro destino dei ribelli siriani, c’è il riconoscimento di Gerusalemme tutta ebraica e di tutta la colonizzazione ebraica in Palestina il che significa chiudere ermeticamente ogni processo di pace, mentre la messa in discussione dell’accordo nucleare con l’Iran non diminuirà certo la tensione.
In sostanza per il momento sembra che non resti che prendere atto dell’uragano Trump cercando di tenere in piedi ancora il numero maggiore di cose che abbiamo e riempiendo la vasca da bagno per ogni emergenza come si fa di fronte ad ogni ciclone. Vedremo già nelle settimane che verranno se il ciclone diventerà soltanto un vento che rovescia gli ombrelli, ma non spazza via costruzioni politiche messe in piedi con il lavoro di più di mezzo secolo.
E tuttavia il fenomeno Trump ci dovrebbe già insegnare che la rabbia della gente porta oggi soprattutto a destra mentre in passato portava quasi sempre a sinistra. Solo nel 1933 in Germania portò alla destra più terribile che si ricordi. E si impone una riflessione che riguarda soprattutto una sinistra purtroppo sempre più perdente ovunque, se perfino in America, che in teoria dovrebbe essere la nazione più ricca e fortunata del mondo, la povertà porta a scegliere un plurimiliardario. In realtà anche l’America è oggi un paese in cui l’uno per cento degli americani possiede il venti per cento delle ricchezze del paese, come ricorda il movimento Occupy Wall Street, in cui la disoccupazione è solo nascosta dalle statistiche, in cui gli operai dell’industria automobilistica di Detroit sono stati sostituiti dai camerieri delle pizzerie e dei bar pagati con le mance a nove dollari (sette euro) l’ora, in cui solo un lavoratore su cento è iscritto ad un sindacato, in cui più della metà della popolazione vive in compagnia degli ansiolitici e una parte addirittura con l’«aiuto» dell’alcool o dell’eroina, con un aumento dei casi di cancro del 50% nella fascia di età fra 45 e i 55 anni, l’età tragica in cui il lavoro si perde e non si ritrova. Anche e soprattutto nella sinistra c’è bisogno di una riflessione sul liberismo e sulla globalizzazione degli ultimi venti anni spesso condivisi, ma che hanno portato a questo disastro economico trasformatosi in disastro politico.